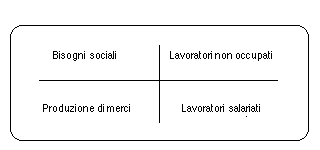Il Fondo monetario internazionale prevede che nel 2013 i paesi occidentali, cioè quelli più ricchi al mondo almeno dai tempi della rivoluzione industriale, scenderanno nelle quote di Pil globale al disotto del 50%. Forse la definizione di paesi emergenti per nazioni quali Cina, India, Brasile e molti altri è da mettere in soffitta. Certamente restano enormi divari nelle proporzioni pro-capite a tutto vantaggio dei paesi di antica industrializzazione. Nonostante il cambio degli equilibri e dei connotati dell’economia mondiale però i percorsi per uscire dalla crisi non si semplificano. I paesi ormai emersi non rappresentano una possibile via di uscita dalla crisi globale, almeno nel breve periodo. Dopo la precipitazione del 2008-09, un paese come la Cina veniva considerato la nuova possibile locomotiva della ripresa. A distanza di cinque anni si registra una consistente diminuzione della sua crescita. Restano numeri importanti, ma forse non adeguati ai ritmi precedenti e alle attese create.
A fronte della crisi dei vecchi bastioni del capitalismo, i nuovi protagonisti dell’economia contemporanea non potevano restarne immuni, considerati i loro assetti sbilanciati verso l’export. Il buco nero rappresentato dall’Europa pesa enormemente sulla Cina che aveva nel Vecchio continente il principale importatore delle proprie merci. D’altronde c’è una sfasatura temporale tra la necessità di riprendersi dei paesi occidentali, scommettendo sulle esportazioni, e l’incapacità, in tempi ragionevoli, di ri-centrare il proprio modello di sviluppo degli ex-emergenti. Aumentare ulteriormente lo sviluppo interno anziché esportare e acquistare titoli di debito dei paesi occidentali non sarà operazione che si risolve rapidamente, per la Cina e non solo.
Ma i problemi non finiscono qui. Negli ultimi giorni le difficoltà registrate dalle borse orientali indicano come il capitalismo globale abbia utilizzato formule molto simili per arginare la crisi. L’annuncio della Fed sulla riduzione della politica monetaria espansiva, unica vera arma utilizzata in questi anni, ha mandato in fibrillazione paesi molto differenti tra loro. In questi anni, infatti, l’economia a debito non è stata prerogativa unicamente dei paesi occidentali. Nel 2012 in Cina il credito ha raggiunto proporzioni doppie rispetto al Pil, come già per gli Usa ante-crisi. In questo paese è stata praticata una via finanziaria alla crescita fondata sullo sviluppo non controllato del debito privato, con un preoccupante lassismo nei controlli, eccessi e mal distribuzione di liquidità. Così sono emersi timori per la scarsità di liquidità nell’Impero Celeste. Anche perché la moneta immessa nel sistema non si è riversata prevalentemente sulle attività produttive tradizionali. Qualche giorno fa il Sole 24 ore metteva in evidenza un caso da manuale di questo processo, quello della Youngor, imponente società cinese specializzata nel tessile, che si è trasformata da azienda produttiva in grande gruppo immobiliare e finanziario dal futuro molto incerto: «dal tessile al mattone alla finanza, fine della parabola di un’azienda modello». Un percorso che potremmo confondere con quello di tante aziende del capitalismo maturo, per non dire in disfacimento. Se persino la cosiddetta fabbrica del mondo in breve tempo si inserisce nel modello della finanziarizzazione, rendendo sempre più lontana l’ambizione a separare economia reale e finanziaria, allora forse non devono stupire le rivolte turche e brasiliane o le lotte operaie cinesi, cioè quel protagonismo giovanile di una generazione che vive in prima persona le contraddizioni sistemiche dell’attuale economia di mercato a qualsiasi latitudine.
A fronte della crisi dei vecchi bastioni del capitalismo, i nuovi protagonisti dell’economia contemporanea non potevano restarne immuni, considerati i loro assetti sbilanciati verso l’export. Il buco nero rappresentato dall’Europa pesa enormemente sulla Cina che aveva nel Vecchio continente il principale importatore delle proprie merci. D’altronde c’è una sfasatura temporale tra la necessità di riprendersi dei paesi occidentali, scommettendo sulle esportazioni, e l’incapacità, in tempi ragionevoli, di ri-centrare il proprio modello di sviluppo degli ex-emergenti. Aumentare ulteriormente lo sviluppo interno anziché esportare e acquistare titoli di debito dei paesi occidentali non sarà operazione che si risolve rapidamente, per la Cina e non solo.
Ma i problemi non finiscono qui. Negli ultimi giorni le difficoltà registrate dalle borse orientali indicano come il capitalismo globale abbia utilizzato formule molto simili per arginare la crisi. L’annuncio della Fed sulla riduzione della politica monetaria espansiva, unica vera arma utilizzata in questi anni, ha mandato in fibrillazione paesi molto differenti tra loro. In questi anni, infatti, l’economia a debito non è stata prerogativa unicamente dei paesi occidentali. Nel 2012 in Cina il credito ha raggiunto proporzioni doppie rispetto al Pil, come già per gli Usa ante-crisi. In questo paese è stata praticata una via finanziaria alla crescita fondata sullo sviluppo non controllato del debito privato, con un preoccupante lassismo nei controlli, eccessi e mal distribuzione di liquidità. Così sono emersi timori per la scarsità di liquidità nell’Impero Celeste. Anche perché la moneta immessa nel sistema non si è riversata prevalentemente sulle attività produttive tradizionali. Qualche giorno fa il Sole 24 ore metteva in evidenza un caso da manuale di questo processo, quello della Youngor, imponente società cinese specializzata nel tessile, che si è trasformata da azienda produttiva in grande gruppo immobiliare e finanziario dal futuro molto incerto: «dal tessile al mattone alla finanza, fine della parabola di un’azienda modello». Un percorso che potremmo confondere con quello di tante aziende del capitalismo maturo, per non dire in disfacimento. Se persino la cosiddetta fabbrica del mondo in breve tempo si inserisce nel modello della finanziarizzazione, rendendo sempre più lontana l’ambizione a separare economia reale e finanziaria, allora forse non devono stupire le rivolte turche e brasiliane o le lotte operaie cinesi, cioè quel protagonismo giovanile di una generazione che vive in prima persona le contraddizioni sistemiche dell’attuale economia di mercato a qualsiasi latitudine.





 Un giudizio costituzionale aggrovigliato
Un giudizio costituzionale aggrovigliato Le Costituzioni nate dalla sconfitta delle dittature in Europa sono ormai considerate una palla al piede dai poteri forti. Loro parlano chiaro mentre l'ipocrisia è il linguaggio della sconfitta.
Le Costituzioni nate dalla sconfitta delle dittature in Europa sono ormai considerate una palla al piede dai poteri forti. Loro parlano chiaro mentre l'ipocrisia è il linguaggio della sconfitta. Giorgio Lunghini nel suo “
Giorgio Lunghini nel suo “