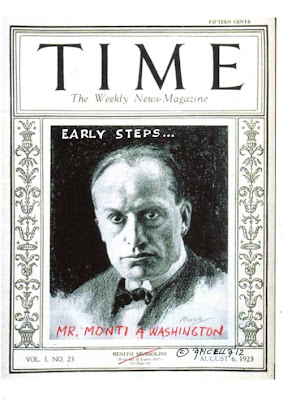di Domenico Moro leparoleelecose
1. Sovrapproduzione e crisi
Secondo la maggior parte dei mass media, degli economisti e dei governi, quella attuale è una crisi finanziaria, che successivamente si sarebbe estesa all’economia “reale”. Con questo tipo di analisi si coglie, però, solo la forma in cui la crisi si è manifestata. Se ne ignora invece il contenuto, che risiede nei meccanismi di accumulazione del capitale. Infatti, le crisi sono la modalità tipica in cui emergono le contraddizioni del modo di produzione attuale. La principale di queste contraddizioni è quella tra produzione e mercato. Lo scopo delle imprese è produrre per fare profitti e per fare ciò riducono i costi delle merci in modo da aumentare il loro margine, cioè la differenza tra costi e prezzi di produzione. La riduzione dei costi di produzione passa per la realizzazione di economie di scala, cioè per la produzione di masse di merci sempre più grandi nello stesso tempo di lavoro. A questo scopo vengono introdotte tecnologia e macchine sempre più moderne al posto di lavoratori, e aumentati ritmi e intensità del lavoro. Astrattamente si tratta di un fatto positivo, in quanto lo sviluppo della produttività mette a disposizione dei consumatori masse di merci più grandi prodotte in un tempo minore. Il problema è che la produzione capitalistica è diretta non verso semplici consumatori ma verso consumatori in grado di pagare un prezzo adeguato a raggiungere il profitto atteso, cioè verso un mercato. Ebbene la questione è proprio questa: la produzione capitalistica è una produzione che si estende progressivamente senza alcun riguardo per il mercato cioè per le capacità di acquisto delle merci prodotte. Inoltre, visto che il profitto è dato dal lavoro non pagato dei lavoratori, la riduzione proporzionale di questi ultimi sul capitale complessivo impiegato provoca una caduta del saggio di profitto [1], che si cerca di compensare con l’aumento dello sfruttamento e quindi producendo un numero maggiore di merci. Tutto questo implica che la produzione tende sempre ad eccedere le capacità di assorbimento del mercato, determinando un permanente squilibrio tra le capacità produttive e la limitatezza del mercato. Una limitatezza che viene accentuata proprio dal meccanismo che sostituisce forza lavoro con macchinari e che conseguentemente provoca l’espulsione di lavoratori dal processo produttivo. Secondo uno studio della Banca dei regolamenti internazionali [2], dagli anni ’80 ad oggi in tutti i principali paesi industrializzati si è avuto uno spostamento del Pil dai salari ai profitti. In Italia la quota andata ai profitti è aumentata dal 23,1% del 1993 al 31,3% del 2005. Si tratta dell’8% del Pil, equivalente a 120 miliardi di euro ossia a 7mila euro per ognuno dei 17 milioni di salariati italiani che annualmente passano dai salari ai profitti. Ma la cosa più interessante dello studio della Bri è che la causa di questo fenomeno viene individuata, non nella concorrenza dei lavoratori dei paesi “in via di sviluppo”, ma nella introduzione di nuova tecnologia che, espellendo lavoratori e destrutturando l’organizzazione del lavoro, riduce le capacità di resistenza e negoziazione dei lavoratori. In questo modo, si è determinata la perdita di capacità d’acquisto dei salari ed i lavoratori si sono trovati costretti al lavoro straordinario con l’effetto di ridurre ancora di più la domanda di forza lavoro e di aggravare la disoccupazione. Inoltre, avendo le nuove tecnologie una forte componente informatica, che diventa obsoleta più rapidamente, le ristrutturazioni sono divenute più frequenti. Dunque, mentre da una parte si moltiplica l’offerta di merci sul mercato, dall’altra parte si riduce la domanda, che per la maggior parte è costituita da lavoratori salariati, o, nel caso migliore, non si permette alla domanda di crescere in modo proporzionale all’offerta. Del resto, nella anarchia della concorrenza, ancorché oligopolistica, che regna nel modo di produzione capitalistico, ogni singolo capitale, per battere i concorrenti, tende a realizzare sempre maggiori economie di scala e a ridurre i salari dei propri lavoratori, trattandoli come costi da ridurre e non come compratori. Si produce così una tendenza alla sovrapproduzione di merci che, però, ha alla sua base la sovrapproduzione di capitale sotto forma di mezzi di produzione. Ciò che è importante capire, però, è che la sovraccapacità produttiva è tale entro il modo di produzione capitalistico, che produce solo per il profitto, e che la sovrapproduzione di merci si determina entro i limiti del mercato capitalistico.
1. Sovrapproduzione e crisi
Secondo la maggior parte dei mass media, degli economisti e dei governi, quella attuale è una crisi finanziaria, che successivamente si sarebbe estesa all’economia “reale”. Con questo tipo di analisi si coglie, però, solo la forma in cui la crisi si è manifestata. Se ne ignora invece il contenuto, che risiede nei meccanismi di accumulazione del capitale. Infatti, le crisi sono la modalità tipica in cui emergono le contraddizioni del modo di produzione attuale. La principale di queste contraddizioni è quella tra produzione e mercato. Lo scopo delle imprese è produrre per fare profitti e per fare ciò riducono i costi delle merci in modo da aumentare il loro margine, cioè la differenza tra costi e prezzi di produzione. La riduzione dei costi di produzione passa per la realizzazione di economie di scala, cioè per la produzione di masse di merci sempre più grandi nello stesso tempo di lavoro. A questo scopo vengono introdotte tecnologia e macchine sempre più moderne al posto di lavoratori, e aumentati ritmi e intensità del lavoro. Astrattamente si tratta di un fatto positivo, in quanto lo sviluppo della produttività mette a disposizione dei consumatori masse di merci più grandi prodotte in un tempo minore. Il problema è che la produzione capitalistica è diretta non verso semplici consumatori ma verso consumatori in grado di pagare un prezzo adeguato a raggiungere il profitto atteso, cioè verso un mercato. Ebbene la questione è proprio questa: la produzione capitalistica è una produzione che si estende progressivamente senza alcun riguardo per il mercato cioè per le capacità di acquisto delle merci prodotte. Inoltre, visto che il profitto è dato dal lavoro non pagato dei lavoratori, la riduzione proporzionale di questi ultimi sul capitale complessivo impiegato provoca una caduta del saggio di profitto [1], che si cerca di compensare con l’aumento dello sfruttamento e quindi producendo un numero maggiore di merci. Tutto questo implica che la produzione tende sempre ad eccedere le capacità di assorbimento del mercato, determinando un permanente squilibrio tra le capacità produttive e la limitatezza del mercato. Una limitatezza che viene accentuata proprio dal meccanismo che sostituisce forza lavoro con macchinari e che conseguentemente provoca l’espulsione di lavoratori dal processo produttivo. Secondo uno studio della Banca dei regolamenti internazionali [2], dagli anni ’80 ad oggi in tutti i principali paesi industrializzati si è avuto uno spostamento del Pil dai salari ai profitti. In Italia la quota andata ai profitti è aumentata dal 23,1% del 1993 al 31,3% del 2005. Si tratta dell’8% del Pil, equivalente a 120 miliardi di euro ossia a 7mila euro per ognuno dei 17 milioni di salariati italiani che annualmente passano dai salari ai profitti. Ma la cosa più interessante dello studio della Bri è che la causa di questo fenomeno viene individuata, non nella concorrenza dei lavoratori dei paesi “in via di sviluppo”, ma nella introduzione di nuova tecnologia che, espellendo lavoratori e destrutturando l’organizzazione del lavoro, riduce le capacità di resistenza e negoziazione dei lavoratori. In questo modo, si è determinata la perdita di capacità d’acquisto dei salari ed i lavoratori si sono trovati costretti al lavoro straordinario con l’effetto di ridurre ancora di più la domanda di forza lavoro e di aggravare la disoccupazione. Inoltre, avendo le nuove tecnologie una forte componente informatica, che diventa obsoleta più rapidamente, le ristrutturazioni sono divenute più frequenti. Dunque, mentre da una parte si moltiplica l’offerta di merci sul mercato, dall’altra parte si riduce la domanda, che per la maggior parte è costituita da lavoratori salariati, o, nel caso migliore, non si permette alla domanda di crescere in modo proporzionale all’offerta. Del resto, nella anarchia della concorrenza, ancorché oligopolistica, che regna nel modo di produzione capitalistico, ogni singolo capitale, per battere i concorrenti, tende a realizzare sempre maggiori economie di scala e a ridurre i salari dei propri lavoratori, trattandoli come costi da ridurre e non come compratori. Si produce così una tendenza alla sovrapproduzione di merci che, però, ha alla sua base la sovrapproduzione di capitale sotto forma di mezzi di produzione. Ciò che è importante capire, però, è che la sovraccapacità produttiva è tale entro il modo di produzione capitalistico, che produce solo per il profitto, e che la sovrapproduzione di merci si determina entro i limiti del mercato capitalistico.