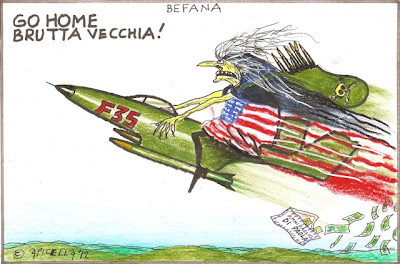di Giulietto Chiesa. Fonte: megachipdue
di Giulietto Chiesa. Fonte: megachipdueAccadde a luglio del 2011, alla vigilia del vertice del G-20. Il mondo del mainstream, istruito per farci vedere il varieté, ci raccontò gl’incontri dei grandi e dei meno grandi, ma non ci disse niente in prima pagina sul posto dove quelle loro - si fa per dire - decisioni erano state prese, prima che costoro si riunissero.
Soprattutto si è guardato bene dal dirci “chi” erano quelli che le avevano prese, e poi, opportunamente confezionate, le avevano fatte servire agl’ignari abitanti di Matrix.
Il luogo fu Basilea, la città cui è toccato di scandire, con la precisione degli orologi svizzeri, il cambio d’epoca cui siamo forzati ad assistere. Si chiamano “Basilea 1”, “Basilea 2”, “Basilea 3” (in fieri) , le tappe in cui i regolamenti finanziari sono stati definiti negli scorsi anni. Basilea non per un capriccio del destino, ma perché è la sede della Bank for International Settlements, cioè la superbanca delle superbanche, il luogo dove si decidono le regole delle banche, cioè ormai degli Stati (dal momento che questi ultimi sono dei nani al servizio dei ciclopi); il tempio dove si stabilisce il grado di libertà che le superbanche intendono riservarsi nel loro agire.
A luglio 2010 non si tenne una “Basilea 3” definitiva, ma di sicuro quella riunione resterà nella storia del capitalismo finanziario mondiale, perché fu là che si misurarono i rapporti di forza tra i potenti del pianeta, per meglio dire tra i potenti dell’Occidente, perché fu tra di loro che si regolarono - provvisoriamente - i conti. Erano sei mesi fa e, a occhio e croce, si può dire che quella partita è già finita e se ne stanno aprendo altre, probabilmente assi più dure di quella.
Saranno scontri violentissimi, perché violenti sono gl’interessi che collidono. Questo anche per dire - a un considerevole numero di illusi, che continuano a ripetere questo luogo comune - che non esiste a tutt’oggi alcun “ordine mondiale” e che, anzi siamo in pieno caos mondiale, in cui i veri detentori del potere, i “proprietari universali” sono impegnati in lotte senza quartiere, per stabilire chi sopravviverà e chi dovrà morire, chi resisterà e chi sarà travolto.
I partecipanti erano in 50 , in rappresentanza di 27 paesi dell’occidente. Scrivo “in rappresentanza” non perché qualcuno di voi, lettori, li abbia indicati come suoi rappresentanti. Si sono rappresentati da sé, non hanno bisogno di voi e di noi. Sono quelli che davvero contano, sono quelli che decidono, dopo essersi accoltellati fraternamente.
I loro nomi, salvo quelli di alcuni, non sono importanti. La loro forza è l’anonimato. Compaiono raramente sulle prime pagine dei giornali, sono, a loro modo, figure di secondo piano. Ma alle riunioni del Bilderberg, dove non si fanno fotografie, siedono nelle primissime file e, a conferma della loro importanza, anche i loro conti bancari sono superlativi e le loro proprietà sono introvabili sebbene siano sterminate.
Conta dunque sapere piuttosto “chi rappresentavano”. Conta sapere “cosa” rappresentavano.
Erano, sono i “i rappresentanti del capitale finanziario dell’Occidente”, i gestori del denaro. La crema del denaro. E, a quell’incontro, partecipavano simultaneamente i banchieri globali e i controllori globali dei banchieri globali. Tutti insieme. Poiché, sia chiaro, i controllori globali non possono controllare un bel niente se non c’è il consenso dei controllati. Che quindi non si vede bene come possano essere controllati, visto che possono - se occorre - mandare a spasso anche i controllori, nominandone altri disponibili a controllare meno e a condividere di più.
Questa è la regola del loro club. Che non ha nulla a che vedere né con le regole giuridiche che valgono per i comuni mortali, né con quelle del mercato internazionale. Ecco perché a Basilea non c’erano i maggiordomi della politica internazionale, quelli che poi si sarebbero incontrati al G-20. Quelli non contano quasi niente, quelli servono il caffè.