Di John Pilger - znetitaly -
20 settembre 2012
L’uccisione di 34 minatori da parte della polizia sudafricana che ha sparato alle spalle a molti di loro, impedisce l’illusione della democrazia del dopo-apartheid e fa luce sulla nuova apartheid che c’è in tutto il mondo della quale il Sudafrica è sia un modello storico che contemporaneo. Nel 1894, molto tempo prima che la famigerata parola in lingua Afrikaans pronosticava “uno sviluppo separato” per la maggioranza della gente del Sudafrica, un inglese, Cecil John Rhodes, supervisionava l’Atto Glen Grey * in quella che era allora la Colonia del Capo (ora Città del Capo, n.d.t. ) Questo era designato a costringere i neri a passare dall’agricoltura a un esercito di lavoro a poco prezzo, principalmente per lavorare nelle miniere d’oro e di altri minerali preziosi da poco scoperte. Come risultato di questo darwinismo sociale, la compagnia di Rodes, la De Beers, si sviluppò rapidamente come monopolio mondiale, rendendolo favolosamente ricco. Dato che seguiva il liberalismo in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, fu celebrato come un filantropo che sosteneva nobili cause.
Oggi la borsa di studio Rhodes all’Università di Oxford, è apprezzata nell’ambito delle elite liberali. Gli studiosi di successo che hanno avuto la Rhodes devono dimostrare “forza morale e carattere” e “comprensione e protezione dei deboli e altruismo, benevolenza e fratellanza. L’ex presidente Bill Clinton è uno di loro, il generale Wesley Clark che ha guidato l’attacco della NATO contro la Iugoslavia, è un altro. Il muro noto come apartheid è stato costruito a beneficio di pochi, non ultime le persone più ambiziose della borghesia.
Questo è stato una specie di tabù durante gli anni della segregazione razziale. I Sudafricani di discendenza inglese potevano permettersi un’apparente opposizione all’ossessione dei Boeri per la razza, e il loro disprezzo per gli stessi Boeri, e allo stesso tempo fornivano le facciate dietro le quali un sistema disumano garantiva privilegi basati sulla razza e, cosa più importante, sulla classe sociale.
La nuova elite di colore in Sudafrica, i cui i numeri e influenza sono cresciuti progressivamente durante gli ultimi anni della segregazione razziale, hanno capito la parte che avrebbero avuto seguendo la “liberazione”. La loro “missione storica”, ha scritto Franz Fanon nel suo classico The Wretched of the Earth [Gli sventurati della terra, “non ha nulla a che fare con la trasformazione del paese: essa consiste, prosaicamente, nell’essere la linea di trasmissione tra la nazione e il capitalismo rampante anche se camuffato”.
Questo si adattava alle figure guida del capo della Congresso Nazionale Africano (ANC – African National Congress), Cecil Ramaphosa, capo dell’Unione nazionale dei minatori, ora multi milionario delle grosse imprese, che ha negoziato un “patto” di condivisione del potere con il regime di F.W de Klerk e di Nelson Mandela stesso, la cui devozione per uno “storico compromesso” significava che la libertà dalla povertà e dalla disuguaglianza della maggior parte delle persone era una libertà troppo lontana. Questo è diventato chiaro già nel 1985 quando un gruppo di industriali sudafricani, guidati da Gavin Reilly, presidente della compagnia mineraria anglo-americana, si è incontrato con i preminenti funzionari dell’ANC in Zambia ed entrambe le parti sono state d’accordo, di fatto, che la segregazione razziale sarebbe stata sostituita dalla segregazione economica, nota come “libero mercato”.
Ο παγκοσμοποιημένος καπιταλισμός βλάπτει σοβαρά την υγεία σας.
Il capitalismo globalizzato nuoce gravemente alla salute....
.... e puo' indurre, nei soggetti piu' deboli, alterazioni della vista e dell'udito, con tendenza all'apatia e la graduale perdita di coscienza ...
(di classe) :-))
Il capitalismo globalizzato nuoce gravemente alla salute....
.... e puo' indurre, nei soggetti piu' deboli, alterazioni della vista e dell'udito, con tendenza all'apatia e la graduale perdita di coscienza ...
(di classe) :-))
Francobolllo
Francobollo.
Sarà un caso, ma adesso che si respira nuovamente aria fetida di destra smoderata e becera la polizia torna a picchiare la gente onesta.
Sarà un caso, ma adesso che si respira nuovamente aria fetida di destra smoderata e becera la polizia torna a picchiare la gente onesta.
Europa, SVEGLIA !!

sabato 22 settembre 2012
venerdì 21 settembre 2012
«Le persone diligenti non guadagnano abbastanza per vivere»
Ricchi e poveri sempre più lontani


di Stefano Casertano
«Le persone diligenti non guadagnano abbastanza per vivere»; «Anche chi ha un’educazione universitaria deve barcamenarsi tra stage e contratti a termine»; «Il primo 10% delle famiglie più ricche possiede il 56% del patrimonio privato, e la ricchezza deriva per la maggior parte da eredità». Sono alcune delle frasi pronunciate dagli ospiti del salotto di Anne Will, nel talk-show più importante del primo canale tedesco, la sera di mercoledì 19 settembre.
Era presente anche la giornalista Kathrin Fischer, autrice di un libro-denuncia sul declino della classe media tedesca, Generazione laminato.
A ispirare il titolo sarebbe stato il fatto che nel suo appartamento in affitto a Francoforte il pavimento non fosse in parquet.
Era presente anche la giornalista Kathrin Fischer, autrice di un libro-denuncia sul declino della classe media tedesca, Generazione laminato.
A ispirare il titolo sarebbe stato il fatto che nel suo appartamento in affitto a Francoforte il pavimento non fosse in parquet.
Non è un tema ispirato da particolari fatti di cronaca, ma da un sentimento d’incertezza economica sempre più diffuso tra la piccola borghesia tedesca. Nonostante record di crescita al 3%, la percezione è che la ricchezza sia distribuita in maniera meno equa rispetto al passato.
Da Anne Will era ospite anche il segretario generale del partito liberale, Patrick Döring, che ha scelto per sé l’impopolare posizione di «difensore dei ricchi» (così la definizione del Berliner Zeitung): la ricchezza sarebbe «frutto del lavoro e della capacità di prendere rischi», tanto che un’imposizione statale per la redistribuzione del patrimonio «finirebbe per danneggiare la classe media», anche perché «la metà delle tasse totali è pagata proprio dal 10% più ricco». Del resto, anche «la corte costituzionale [la stessa istituzione che ha deciso recentemente l’accettabilità della partecipazione tedesca al fondo Esm, ndr] ha stabilito che un’imposizione fiscale superiore al 50% è inaccettabile».
I fatti sembrano indicare che la tesi dell’arricchimento dei più ricchi sia attendibile. Secondo un report del ministero del Lavoro, il 10% delle famiglie più benestanti nel 1998 possedeva il 45% del patrimonio, passato al 53% nel 2008, fino all’attuale 56 per cento. La metà delle famiglie più povere possiede solo l’1% del patrimonio. L’«indice di Gini» descrive la qualità della distribuzione del reddito: più è basso, migliore è la situazione. La Germania è posizionata bene, segnando un «28,3» che la colloca vicina alle economie scandinave – mentre l’Italia, a 36, è paragonabile alla Gran Bretagna. Ma ciò che spaventa i tedeschi è il peggioramento della situazione. Economia esportativa, presenza dei grandi gruppi, finanza di Francoforte e necessità di iper-educazione fanno temere alla classe media che la Germania si stia «americanizzando». Si teme che la ricchezza di pochi aumenti a spese di tutti: il report ministeriale indica come tra il 1992 e il 2012 il patrimonio netto dello stato sia diminuito, mentre quello dei privati sia aumentato del 4,6 per cento.
Uwe Hück, membro del cda di Porsche, anch’egli presente da Anne Will, ha richiamato l’élite tedesca alla «responsabilità». Rispondeva Michael Hüther, presidente dell’Istituto Economico Tedesco, che si potrebbe trattare solo di una «questione relativa». Comprare una lavatrice – ha sostenuto – costa oggi la metà rispetto a una decina di anni fa, tanto che la «nuova povertà» sarebbe «un problema di percezione». Forse Hüther ha ragione: è innegabile che rinunciare al parquet in favore del laminato non è esattamente un problema esistenziale.
Eppure, l’insoddisfazione c’è. Impressiona l’incomunicabilità tra «benestanti» e «borghesia impoverita». Il liberale Döring parla al vento: serve a poco ripetere l’abc di Friedman, se nell’immaginario collettivo sono rimasti gli anni Ottanta, con il reddito in aumento, la BMW in garage e una bella villetta in campagna. Si trattava di altri tempi, con un Occidente in trionfo, senza la concorrenza spietata e sleale del «social dumping» cinese. Non si riesce a immaginare un nuovo modello socialmente sostenibile, che sia in grado di confrontarsi con la situazione attuale. Le riforme degli anni Duemila non hanno risolto la piaga sociale dei «disoccupati di professione»: ormai sono nate «dinastie di disoccupati», in cui non si lavora da tre generazioni. La mobilità sociale, pur tra le più dinamiche al mondo, è in peggioramento.
Alla Germania viene chiesto di guidare l’Europa, ma il Paese stesso si dibatte oggi in una crisi di personalità, che deve essere risolta per proporre un modello vero all’estero. La piccola borghesia tedesca non riuscirà mai davvero a interessarsi dei problemi di Grecia e Spagna, se prima non risolverà i propri.
Da Anne Will era ospite anche il segretario generale del partito liberale, Patrick Döring, che ha scelto per sé l’impopolare posizione di «difensore dei ricchi» (così la definizione del Berliner Zeitung): la ricchezza sarebbe «frutto del lavoro e della capacità di prendere rischi», tanto che un’imposizione statale per la redistribuzione del patrimonio «finirebbe per danneggiare la classe media», anche perché «la metà delle tasse totali è pagata proprio dal 10% più ricco». Del resto, anche «la corte costituzionale [la stessa istituzione che ha deciso recentemente l’accettabilità della partecipazione tedesca al fondo Esm, ndr] ha stabilito che un’imposizione fiscale superiore al 50% è inaccettabile».
I fatti sembrano indicare che la tesi dell’arricchimento dei più ricchi sia attendibile. Secondo un report del ministero del Lavoro, il 10% delle famiglie più benestanti nel 1998 possedeva il 45% del patrimonio, passato al 53% nel 2008, fino all’attuale 56 per cento. La metà delle famiglie più povere possiede solo l’1% del patrimonio. L’«indice di Gini» descrive la qualità della distribuzione del reddito: più è basso, migliore è la situazione. La Germania è posizionata bene, segnando un «28,3» che la colloca vicina alle economie scandinave – mentre l’Italia, a 36, è paragonabile alla Gran Bretagna. Ma ciò che spaventa i tedeschi è il peggioramento della situazione. Economia esportativa, presenza dei grandi gruppi, finanza di Francoforte e necessità di iper-educazione fanno temere alla classe media che la Germania si stia «americanizzando». Si teme che la ricchezza di pochi aumenti a spese di tutti: il report ministeriale indica come tra il 1992 e il 2012 il patrimonio netto dello stato sia diminuito, mentre quello dei privati sia aumentato del 4,6 per cento.
Uwe Hück, membro del cda di Porsche, anch’egli presente da Anne Will, ha richiamato l’élite tedesca alla «responsabilità». Rispondeva Michael Hüther, presidente dell’Istituto Economico Tedesco, che si potrebbe trattare solo di una «questione relativa». Comprare una lavatrice – ha sostenuto – costa oggi la metà rispetto a una decina di anni fa, tanto che la «nuova povertà» sarebbe «un problema di percezione». Forse Hüther ha ragione: è innegabile che rinunciare al parquet in favore del laminato non è esattamente un problema esistenziale.
Eppure, l’insoddisfazione c’è. Impressiona l’incomunicabilità tra «benestanti» e «borghesia impoverita». Il liberale Döring parla al vento: serve a poco ripetere l’abc di Friedman, se nell’immaginario collettivo sono rimasti gli anni Ottanta, con il reddito in aumento, la BMW in garage e una bella villetta in campagna. Si trattava di altri tempi, con un Occidente in trionfo, senza la concorrenza spietata e sleale del «social dumping» cinese. Non si riesce a immaginare un nuovo modello socialmente sostenibile, che sia in grado di confrontarsi con la situazione attuale. Le riforme degli anni Duemila non hanno risolto la piaga sociale dei «disoccupati di professione»: ormai sono nate «dinastie di disoccupati», in cui non si lavora da tre generazioni. La mobilità sociale, pur tra le più dinamiche al mondo, è in peggioramento.
Alla Germania viene chiesto di guidare l’Europa, ma il Paese stesso si dibatte oggi in una crisi di personalità, che deve essere risolta per proporre un modello vero all’estero. La piccola borghesia tedesca non riuscirà mai davvero a interessarsi dei problemi di Grecia e Spagna, se prima non risolverà i propri.
linkiesta.it
“Se non si può riformare, meglio la fine dell’euro”
- rifondazione -

Si passa dall’industria ai servizi. Abbiamo un’industria che funziona molto bene, che è molto produttiva. Ma fornisce molti meno posti di lavoro rispetto a prima. Tanto più che in parte se ne vanno nei paesi emergenti. I mercati non rendono un buon servizio per questo. C’è uno spazio da occupare per i governi.
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa della crisi europea e delle misure di rigore e di austerità che i leader della zona euro ci fanno passare come le sole e uniche soluzioni per superare questa crisi.
L’austerità non è la soluzione. Non permette ai governi di aiutare le imprese a passare dalla vecchia alla nuova economia. Al contrario, essa limita le possibilità di sostegno.
Ora l’economia in Occidente sta passando dall’industria ai servizi: l’istruzione, la sanità, la cultura, il turismo, ecc. La cosa interessante è che tra questi settori, molti sono pubblici. Questo è il motivo per cui avremo sempre più bisogno dei nostri governi, ancora più che per l’industria, che già richiedeva l’intervento dello Stato. Il settore pubblico non deve solo dirottare il suo sostegno verso i nuovi settori, ma deve anche rafforzarlo.
Ad esempio, negli Stati Uniti, spendiamo troppi soldi per la difesa. Produciamo molte armi che non servono a combattere contro tutti questi nemici che non esistono. E’ spreco di denaro. Si finanziano anche molto le imprese, invece che i dipendenti. Sono degli esempi. È possibile riorientare la spesa verso quello che serve a rafforzare l’economia del futuro.
In Francia, la crescita ha subito un rallentamento, ma François Hollande ha annunciato tagli alla spesa e aumenti delle tasse che peseranno sulla crescita, per raggiungere gli obiettivi europei. Ci sta portando nel precipizio?
Limitare il disavanzo strutturale, come previsto dai trattati europei, funziona quando si è in piena occupazione, ma non quando si è in una fase di recessione. E’ irresponsabile cercare di avere un bilancio in pareggio o addirittura un disavanzo strutturale al 3% in una economia debole.
Penso che la decisione di François Hollande avrà conseguenze molto negative. L’austerità conduce alla recessione. L’austerità in Spagna ha portato alla depressione.
I leader europei tuttavia continuano a dire che la crescita è necessaria. E’ quello che continuano a ripetere da anni, ma non hanno proposto nulla di concreto in questa direzione. Ci sono stati alcuni progressi, ma arrivano molto lentamente e non saranno sufficienti.
Ad esempio, avete rafforzato la Banca europea per gli investimenti per consentirle di fare più investimenti. Ma la misura di ciò che viene proposto è troppo scarsa. Non sarà sufficiente a compensare i danni dell’austerità.
Non c’è un altro modo per rilanciare l’economia? Se è così, perché i capi di Stato europei insistono in questa direzione?
Il grande errore degli europei, e della Germania in primo luogo, è che fanno una diagnosi sbagliata del problema. Essi credono che la crisi derivi da un atteggiamento troppo spendaccione. Ma l’Irlanda e la Spagna prima della crisi erano in surplus . Non sono state le spese a mandarle a fondo.
E’ la crisi economica che ha causato il deficit, non il deficit che ha causato il rallentamento. Introdurre una maggiore austerità non farà che esacerbare la crisi. Ma i leader europei non lo capiscono.
Cosa bisogna fare?
L’area dell’euro soffre principalmente di un problema di regole, e i dirigenti non se ne occupano. Devono farlo. Essi devono:

Intervista a Joseph Stiglitz
Quali pensate che siano le cause della crisi economica mondiale? E’ semplicemente una “classica” crisi di sovrapproduzione?
Non è una crisi di sovrapproduzione. Il problema è la mancanza di domanda. Ma dietro c’è un altro problema: gli Stati Uniti e l’Europa avranno bisogno di cambiare la struttura delle loro economie. Diventa urgente.
Nel XIX secolo, siamo passati dall’agricoltura all’industria. I lavoratori agricoli erano più del necessario. Hanno dovuto fare qualcosa di diverso e questa altra cosa era la fabbrica. Ora siamo nella stessa situazione.
Non è una crisi di sovrapproduzione. Il problema è la mancanza di domanda. Ma dietro c’è un altro problema: gli Stati Uniti e l’Europa avranno bisogno di cambiare la struttura delle loro economie. Diventa urgente.
Nel XIX secolo, siamo passati dall’agricoltura all’industria. I lavoratori agricoli erano più del necessario. Hanno dovuto fare qualcosa di diverso e questa altra cosa era la fabbrica. Ora siamo nella stessa situazione.
Si passa dall’industria ai servizi. Abbiamo un’industria che funziona molto bene, che è molto produttiva. Ma fornisce molti meno posti di lavoro rispetto a prima. Tanto più che in parte se ne vanno nei paesi emergenti. I mercati non rendono un buon servizio per questo. C’è uno spazio da occupare per i governi.
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa della crisi europea e delle misure di rigore e di austerità che i leader della zona euro ci fanno passare come le sole e uniche soluzioni per superare questa crisi.
L’austerità non è la soluzione. Non permette ai governi di aiutare le imprese a passare dalla vecchia alla nuova economia. Al contrario, essa limita le possibilità di sostegno.
Ora l’economia in Occidente sta passando dall’industria ai servizi: l’istruzione, la sanità, la cultura, il turismo, ecc. La cosa interessante è che tra questi settori, molti sono pubblici. Questo è il motivo per cui avremo sempre più bisogno dei nostri governi, ancora più che per l’industria, che già richiedeva l’intervento dello Stato. Il settore pubblico non deve solo dirottare il suo sostegno verso i nuovi settori, ma deve anche rafforzarlo.
Ad esempio, negli Stati Uniti, spendiamo troppi soldi per la difesa. Produciamo molte armi che non servono a combattere contro tutti questi nemici che non esistono. E’ spreco di denaro. Si finanziano anche molto le imprese, invece che i dipendenti. Sono degli esempi. È possibile riorientare la spesa verso quello che serve a rafforzare l’economia del futuro.
In Francia, la crescita ha subito un rallentamento, ma François Hollande ha annunciato tagli alla spesa e aumenti delle tasse che peseranno sulla crescita, per raggiungere gli obiettivi europei. Ci sta portando nel precipizio?
Limitare il disavanzo strutturale, come previsto dai trattati europei, funziona quando si è in piena occupazione, ma non quando si è in una fase di recessione. E’ irresponsabile cercare di avere un bilancio in pareggio o addirittura un disavanzo strutturale al 3% in una economia debole.
Penso che la decisione di François Hollande avrà conseguenze molto negative. L’austerità conduce alla recessione. L’austerità in Spagna ha portato alla depressione.
I leader europei tuttavia continuano a dire che la crescita è necessaria. E’ quello che continuano a ripetere da anni, ma non hanno proposto nulla di concreto in questa direzione. Ci sono stati alcuni progressi, ma arrivano molto lentamente e non saranno sufficienti.
Ad esempio, avete rafforzato la Banca europea per gli investimenti per consentirle di fare più investimenti. Ma la misura di ciò che viene proposto è troppo scarsa. Non sarà sufficiente a compensare i danni dell’austerità.
Non c’è un altro modo per rilanciare l’economia? Se è così, perché i capi di Stato europei insistono in questa direzione?
Il grande errore degli europei, e della Germania in primo luogo, è che fanno una diagnosi sbagliata del problema. Essi credono che la crisi derivi da un atteggiamento troppo spendaccione. Ma l’Irlanda e la Spagna prima della crisi erano in surplus . Non sono state le spese a mandarle a fondo.
E’ la crisi economica che ha causato il deficit, non il deficit che ha causato il rallentamento. Introdurre una maggiore austerità non farà che esacerbare la crisi. Ma i leader europei non lo capiscono.
Cosa bisogna fare?
L’area dell’euro soffre principalmente di un problema di regole, e i dirigenti non se ne occupano. Devono farlo. Essi devono:
Italia, dov’è finita la protesta?
- Fonte - Donatelle Della Porta
Di fronte alla crisi e alle politiche di austerità, sembra che l’Italia non risponda più con grandi manifestazioni di protesta. Il rapporto con la politica si allontana e cambiano le dinamiche dei movimenti sociali nel nostro paese
Di fronte alle dure politiche di austerity che, già da tempo ma oggi con maggiore vigore, colpiscono ampie fasce di popolazione (“nove su dieci”, dimostra Mario Pianta), una delle domande spesso rivolte agli studiosi di movimenti sociali (così come ai loro attivisti) è: perché a fronte di una sfida così grande, la mobilitazione si mantiene limitata? Perché – diversamente da Spagna, Grecia e Stati Uniti, ma anche dall’Islanda prima di loro – c’è apparentemente così poca protesta?
Occorre innanzitutto osservare che la protesta c’è, cresce e si focalizza sui temi dei diritti sociali intrecciate con domande di democrazia reale. Una ricerca che abbiamo condotto (con Lorenzo Mosca e Louisa Parks) sulle proteste riportate su un quotidiano nazionale nel 2011, dimostra una mobilitazione non solo elevata, ma anche concentrata su temi sociali. Quasi la metà degli eventi di protesta riportati coinvolge lavoratori (in condizioni occupazionali stabili), oltre la metà se si aggiungono i precari (tabella 1). Più di un quinto coinvolgono studenti. Inoltre, se i sindacati sono ben presenti nella mobilitazione, attori importanti della protesta sono anche gruppi informali di movimenti sociali, centri sociali occupati e associazioni di vario tipo (tabella 2). Non a caso, le statistiche sugli scioperi segnalano un aumento del 25% nell’ultimo anno.
Tabella 1. Tipo di gruppo sociale coinvolto nell’evento di protesta (risposte multiple, percentuale di casi)
Tabella 2. Tipo di organizzazione coinvolte nell’evento di protesta (risposte multiple, percentuale di casi)
Se gli episodi di mobilitazione anti-austerity sono numerosi, è però vero che, negli ultimi mesi, sono mancate le grandi manifestazioni che avevano contribuito alla caduta del governo Berlusconi, segnalando tra l’altro che politiche neoliberiste non potevano essere imposte efficacemente da un capo di governo libertino, e variamente delegittimato. Il passaggio da Berlusconi a Monti non ha segnalato un mutamento di indirizzo delle politiche pubbliche, ma l’acquisto (a prezzi modici, a dire il vero) del sostegno ad esse di quella che era stata l’opposizione politica. Se il 15 ottobre 2011, con una grande capacità di mobilitazione, ha rappresentato un’eccezione, la sua evoluzione non ha facilitato la ripresa di un processo di aggregazione nella protesta – tutt’altro.
Una prima ragione della difficoltà nel mettere in rete le mobilitazioni esistenti può essere individuata nella crisi stessa. Ripetutamente, la ricerca sui movimenti sociali ha sottolineato che non è quando c’è più privazione (né assoluta, ne relativa) che la protesta aumenta, ma piuttosto quando maggiori risorse sono disponibili per chi vuole contestare le decisioni di chi governa. Già gli studi sul movimento operaio hanno rilevato che gli scioperi crescono con la piena occupazione, non quando aumenta la disoccupazione. Se l’insicurezza scoraggia l’azione collettiva, l’effetto depressivo della crisi non può che essere accentuato dal nuovo tipo di mercato del lavoro, e per le nuove figure produttive meno protette sul mercato del lavoro e sul luogo di lavoro. Chi è precario ha, certamente, più difficoltà a mobilitarsi in difesa dei suoi diritti, perché è più ricattabile, ha meno tempo libero, e spesso mancano gli stessi luoghi fisici di aggregazione che erano stati così importanti per il movimento operaio.
Se questo tipo di spiegazione, diciamo strutturale, ha qualche granello di verità, non ci aiuta però a capire perché in Spagna, Grecia, o negli Stati Uniti (ma anche in Italia in altri momenti) i gruppi più colpiti dalla crisi economica e dalle crescenti diseguaglianze prodotte dalle politiche neoliberiste (peraltro responsabili di quella stessa crisi) si sono mobilitati in momenti di protesta ampia e visibile (dagli Indignados a Occupy). I precari hanno, tra l’altro, in Italia protestato in maniera ampia e visibile, in particolare nella prima metà dello scorso decennio.
La ricerca sui movimenti sociali ci offre un’altra spiegazione, più specificamente applicabile al caso italiano. La protesta, per crescere, ha bisogno di alcune opportunità politiche. Fra di esse, fondamentale per i movimenti di sinistra è la posizione di potenziali alleati come partiti e sindacati, che sono importanti per estendere la mobilitazione, sia per le risorse logistiche che possono offrire sia, soprattutto, per la possibilità di accrescere l’influenza politica di chi protesta. È contro governi di centro-destra che la protesta di massa è stata più consistente è visibile, quando ha trovato il sostegno di partiti e sindacati. Ciò è tanto più vero in Italia dove, nonostante reciproche critiche, i rapporti tra movimenti e partiti di sinistra (quando c’erano) erano sempre stati intensi.
Se questi alleati c’erano contro Berlusconi, un governo di grande coalizione come il governo Monti ha drasticamente ridotto le opportunità di alleanze politiche. Non solo partiti che votano per il governo neoliberista e le sue politiche sarebbero alleati poco credibili per chi a quelle politiche si oppone, ma il governo in carica è anche riuscito a propagare efficacemente la sua auto-immagine di “governo tecnico”.
Che questa auto-rappresentazione abbia pochi appigli nella realtà è evidente, tra l’altro guardando alle carriere della maggior parte dei ministri all’interno di istituzioni non certo neutrali rispetto alle scelte politiche, così come nelle politiche di deregolamentazione, privatizzazione, e riduzione della volontà e capacità dello stato di intervenire a ridurre le diseguaglianze prodotte dal mercato.
Ma è anche evidente che l’autorappresentazione come governo tecnico abbia attecchito sulla stampa e oltre. Non solo i principali giornali nazionali inneggiano acriticamente al “super Mario”, ma istituzioni come quelle accademiche, che avevano in passato gelosamente custodito un’immagine di neutralità politica, offrono oggi, spesso e volentieri, un palcoscenico politico al capo di un governo che si autodefinisce tecnico, palcoscenico utilizzato poi per fare discorsi prettamente politici e ideologicamente neoliberisti.
Questa anomalia italiana contribuisce certamente a spiegare la difficoltà di mettere in rete i tanti rivoli della protesta – che pur, appunto, ci sono. Questa resistenza diffusa potrebbe comunque contribuire a una aggregazione e politicizzazione delle mobilitazioni, non solo attraverso la contestazione di specifiche politiche, ma anche sottolineando la natura – politica e neoliberista – di questo governo.
Occorre innanzitutto osservare che la protesta c’è, cresce e si focalizza sui temi dei diritti sociali intrecciate con domande di democrazia reale. Una ricerca che abbiamo condotto (con Lorenzo Mosca e Louisa Parks) sulle proteste riportate su un quotidiano nazionale nel 2011, dimostra una mobilitazione non solo elevata, ma anche concentrata su temi sociali. Quasi la metà degli eventi di protesta riportati coinvolge lavoratori (in condizioni occupazionali stabili), oltre la metà se si aggiungono i precari (tabella 1). Più di un quinto coinvolgono studenti. Inoltre, se i sindacati sono ben presenti nella mobilitazione, attori importanti della protesta sono anche gruppi informali di movimenti sociali, centri sociali occupati e associazioni di vario tipo (tabella 2). Non a caso, le statistiche sugli scioperi segnalano un aumento del 25% nell’ultimo anno.
Tabella 1. Tipo di gruppo sociale coinvolto nell’evento di protesta (risposte multiple, percentuale di casi)
| Gruppo sociale | % |
| Lavoratori | 47,3 |
| Studenti | 21,8 |
| Cittadini (in generale) | 13,6 |
| Donne | 10,9 |
| Lavoratori precari | 10,0 |
| Immigrati o minoranze etniche | 10,0 |
| Intellettuali/artisti/giornalisti | 10,0 |
| Altri | 10,0 |
| Totale (N) | 147 |
Tabella 2. Tipo di organizzazione coinvolte nell’evento di protesta (risposte multiple, percentuale di casi)
| Tipo di organizzazione | % |
| Gruppi di base | 39,4 |
| Sindacati | 36,7 |
| Partiti politici | 33,9 |
| Donne | 15,6 |
| Centri sociali | 10,1 |
| Attori istituzionali | 5,5 |
| Altri | 3,7 |
| Totale (N) | 158 |
Se gli episodi di mobilitazione anti-austerity sono numerosi, è però vero che, negli ultimi mesi, sono mancate le grandi manifestazioni che avevano contribuito alla caduta del governo Berlusconi, segnalando tra l’altro che politiche neoliberiste non potevano essere imposte efficacemente da un capo di governo libertino, e variamente delegittimato. Il passaggio da Berlusconi a Monti non ha segnalato un mutamento di indirizzo delle politiche pubbliche, ma l’acquisto (a prezzi modici, a dire il vero) del sostegno ad esse di quella che era stata l’opposizione politica. Se il 15 ottobre 2011, con una grande capacità di mobilitazione, ha rappresentato un’eccezione, la sua evoluzione non ha facilitato la ripresa di un processo di aggregazione nella protesta – tutt’altro.
Una prima ragione della difficoltà nel mettere in rete le mobilitazioni esistenti può essere individuata nella crisi stessa. Ripetutamente, la ricerca sui movimenti sociali ha sottolineato che non è quando c’è più privazione (né assoluta, ne relativa) che la protesta aumenta, ma piuttosto quando maggiori risorse sono disponibili per chi vuole contestare le decisioni di chi governa. Già gli studi sul movimento operaio hanno rilevato che gli scioperi crescono con la piena occupazione, non quando aumenta la disoccupazione. Se l’insicurezza scoraggia l’azione collettiva, l’effetto depressivo della crisi non può che essere accentuato dal nuovo tipo di mercato del lavoro, e per le nuove figure produttive meno protette sul mercato del lavoro e sul luogo di lavoro. Chi è precario ha, certamente, più difficoltà a mobilitarsi in difesa dei suoi diritti, perché è più ricattabile, ha meno tempo libero, e spesso mancano gli stessi luoghi fisici di aggregazione che erano stati così importanti per il movimento operaio.
Se questo tipo di spiegazione, diciamo strutturale, ha qualche granello di verità, non ci aiuta però a capire perché in Spagna, Grecia, o negli Stati Uniti (ma anche in Italia in altri momenti) i gruppi più colpiti dalla crisi economica e dalle crescenti diseguaglianze prodotte dalle politiche neoliberiste (peraltro responsabili di quella stessa crisi) si sono mobilitati in momenti di protesta ampia e visibile (dagli Indignados a Occupy). I precari hanno, tra l’altro, in Italia protestato in maniera ampia e visibile, in particolare nella prima metà dello scorso decennio.
La ricerca sui movimenti sociali ci offre un’altra spiegazione, più specificamente applicabile al caso italiano. La protesta, per crescere, ha bisogno di alcune opportunità politiche. Fra di esse, fondamentale per i movimenti di sinistra è la posizione di potenziali alleati come partiti e sindacati, che sono importanti per estendere la mobilitazione, sia per le risorse logistiche che possono offrire sia, soprattutto, per la possibilità di accrescere l’influenza politica di chi protesta. È contro governi di centro-destra che la protesta di massa è stata più consistente è visibile, quando ha trovato il sostegno di partiti e sindacati. Ciò è tanto più vero in Italia dove, nonostante reciproche critiche, i rapporti tra movimenti e partiti di sinistra (quando c’erano) erano sempre stati intensi.
Se questi alleati c’erano contro Berlusconi, un governo di grande coalizione come il governo Monti ha drasticamente ridotto le opportunità di alleanze politiche. Non solo partiti che votano per il governo neoliberista e le sue politiche sarebbero alleati poco credibili per chi a quelle politiche si oppone, ma il governo in carica è anche riuscito a propagare efficacemente la sua auto-immagine di “governo tecnico”.
Che questa auto-rappresentazione abbia pochi appigli nella realtà è evidente, tra l’altro guardando alle carriere della maggior parte dei ministri all’interno di istituzioni non certo neutrali rispetto alle scelte politiche, così come nelle politiche di deregolamentazione, privatizzazione, e riduzione della volontà e capacità dello stato di intervenire a ridurre le diseguaglianze prodotte dal mercato.
Ma è anche evidente che l’autorappresentazione come governo tecnico abbia attecchito sulla stampa e oltre. Non solo i principali giornali nazionali inneggiano acriticamente al “super Mario”, ma istituzioni come quelle accademiche, che avevano in passato gelosamente custodito un’immagine di neutralità politica, offrono oggi, spesso e volentieri, un palcoscenico politico al capo di un governo che si autodefinisce tecnico, palcoscenico utilizzato poi per fare discorsi prettamente politici e ideologicamente neoliberisti.
Questa anomalia italiana contribuisce certamente a spiegare la difficoltà di mettere in rete i tanti rivoli della protesta – che pur, appunto, ci sono. Questa resistenza diffusa potrebbe comunque contribuire a una aggregazione e politicizzazione delle mobilitazioni, non solo attraverso la contestazione di specifiche politiche, ma anche sottolineando la natura – politica e neoliberista – di questo governo.
Se parliamo del mercato come se fosse Dio
di Peter Kammerer - sbilanciamoci -
Le categorie dell'economia del libero mercato sono entrate nella nostra lingua, nel nostro modo di pensare e, secondo Erich Fromm, perfino nel nostro subconscio
Liberarsi da questo condizionamento richiede una vera e propria rivoluzione culturale.
Alla «Contro Cernobbio» di Sbilanciamoci Angelo Marano ha chiamato in causa il paradosso fondamentale della nostra epoca: lo sviluppo tecnologico rende possibile, anzi necessario lavorare meno, aumentare il tempo libero. Invece nella realtà rovesciata del capitalismo chi lavora lavora di più, e gli altri rimangono disoccupati o precari, anche loro spesso con orari pesantissimi (di questo ha parlato Andrea Fumagalli).
È lo spreco di una generazione di giovani, che poi vengono incolpati di questo spreco. È saltato ogni tipo di razionalità.
È necessario rifiutare questo lavaggio del cervello, liberare la mente e sciogliere l'enigma ponendo alcune questioni:
1) Chi decide che cosa e come produciamo? Il mercato. Facciamo l'esperimento di sostituire alla parola mercato la parola Dio. Funziona sempre. Si vede che questa risposta viene da un sistema teologico ferreo, fondamentalista (che non ha nulla di liberale).
2) La logica umana vuole che si produca quello di cui abbiamo bisogno. Chi decide quali bisogni siano da soddisfare e quali no? Il mercato. Il mercato rende visibile la domanda dei bisognosi trasformati in consumatori attraverso la domanda effettiva, quella munita di denaro. Questo vuol dire che tutti i bisogni che non si presentano con il denaro in mano rimangono invisibili. La scomparsa della persona umana, (ne ha parlato Gianni Tognoni) è frutto di questo meccanismo.
Per essere «viste», le persone devono presentarsi in modo non economico, cioè politico, ma la politica, accettando i vincoli economici, non li ascolta. Il serpente si morde la coda. La politica non solo abdica (come ha spiegato Luigi Ferrajoli), ma ci prende in giro adducendo una volta i vincoli economici (il caso delle scuole), una volta quelli politici (il caso delle armi).
3) Occorre una rivoluzione mentale: riflettere, studiare come i bisogni si formino e possano articolarsi, e come possano essere soddisfatti con o senza la produzione di merci. C'è una differenza di fondo tra un bisogno soddisfatto attraverso merci e uno soddisfatto attraverso valori d'uso.
4) La merce è un problema da affrontare, pieno di «capricci teologici». Per gli economisti accademici questo non costituisce un problema, ma così si nascondono questioni chiave. Ad esempio, oggi la crisi del lavoro è una crisi del lavoro-merce. Vedendo il lavoro solo come lavoro-merce, sparisce il lavoro-attività e il primo bisogno umano. Il bisogno di lavoro viene ridotto ed appiattito alle categorie di mercato.
Inoltre, se non teniamo conto della natura delle merci, nascondiamo la violenza insita nel mercato e, in generale, il potere delle merci, una violenza che si presenta come libertà (si dovrebbe scrivere la storia delle resistenze popolari al mercato libero, le sue vittorie e le sue sconfitte a partire dal '700).
Per un secolo queste distinzioni, anche all'interno del movimento operaio, apparivano marginali, puramente filosofiche. Oggi sono invece fondamentali e vanno sperimentate nella vita quotidiana.
Alla «Contro Cernobbio» di Sbilanciamoci Angelo Marano ha chiamato in causa il paradosso fondamentale della nostra epoca: lo sviluppo tecnologico rende possibile, anzi necessario lavorare meno, aumentare il tempo libero. Invece nella realtà rovesciata del capitalismo chi lavora lavora di più, e gli altri rimangono disoccupati o precari, anche loro spesso con orari pesantissimi (di questo ha parlato Andrea Fumagalli).
È lo spreco di una generazione di giovani, che poi vengono incolpati di questo spreco. È saltato ogni tipo di razionalità.
È necessario rifiutare questo lavaggio del cervello, liberare la mente e sciogliere l'enigma ponendo alcune questioni:
1) Chi decide che cosa e come produciamo? Il mercato. Facciamo l'esperimento di sostituire alla parola mercato la parola Dio. Funziona sempre. Si vede che questa risposta viene da un sistema teologico ferreo, fondamentalista (che non ha nulla di liberale).
2) La logica umana vuole che si produca quello di cui abbiamo bisogno. Chi decide quali bisogni siano da soddisfare e quali no? Il mercato. Il mercato rende visibile la domanda dei bisognosi trasformati in consumatori attraverso la domanda effettiva, quella munita di denaro. Questo vuol dire che tutti i bisogni che non si presentano con il denaro in mano rimangono invisibili. La scomparsa della persona umana, (ne ha parlato Gianni Tognoni) è frutto di questo meccanismo.
Per essere «viste», le persone devono presentarsi in modo non economico, cioè politico, ma la politica, accettando i vincoli economici, non li ascolta. Il serpente si morde la coda. La politica non solo abdica (come ha spiegato Luigi Ferrajoli), ma ci prende in giro adducendo una volta i vincoli economici (il caso delle scuole), una volta quelli politici (il caso delle armi).
3) Occorre una rivoluzione mentale: riflettere, studiare come i bisogni si formino e possano articolarsi, e come possano essere soddisfatti con o senza la produzione di merci. C'è una differenza di fondo tra un bisogno soddisfatto attraverso merci e uno soddisfatto attraverso valori d'uso.
4) La merce è un problema da affrontare, pieno di «capricci teologici». Per gli economisti accademici questo non costituisce un problema, ma così si nascondono questioni chiave. Ad esempio, oggi la crisi del lavoro è una crisi del lavoro-merce. Vedendo il lavoro solo come lavoro-merce, sparisce il lavoro-attività e il primo bisogno umano. Il bisogno di lavoro viene ridotto ed appiattito alle categorie di mercato.
Inoltre, se non teniamo conto della natura delle merci, nascondiamo la violenza insita nel mercato e, in generale, il potere delle merci, una violenza che si presenta come libertà (si dovrebbe scrivere la storia delle resistenze popolari al mercato libero, le sue vittorie e le sue sconfitte a partire dal '700).
Per un secolo queste distinzioni, anche all'interno del movimento operaio, apparivano marginali, puramente filosofiche. Oggi sono invece fondamentali e vanno sperimentate nella vita quotidiana.
giovedì 20 settembre 2012
In India 50 milioni in piazza contro l'invasione degli Iper
Marco Cedolin - ilcorrosivo -
Anche se la notizia alberga solamente in un articoletto del Corriere e viene praticamente
ignorata dalla maggior parte del circo mainstrem, l'intera India é semi
paralizzata a causa di uno sciopero generale che sta portando in strada 50
milioni di persone. La protesta riguarda un disegno di legge che intende aprire
le porte del paese alle multinazionali straniere del largo consumo, Carrefour,
Tesco e Wal - Mart in primis, ridisegnando in prospettiva il mondo
del commercio al dettaglio in chiave occidentale e condannando alla chiusura decine di
milioni di piccoli commercianti...
Il disegno di legge era già stato proposto una
prima volta nel 2011 e poi tenuto in stand by fino ad oggi, poiché la collera
popolare rischiava di mettere a repentaglio la sopravvivenza del governo. Oggi
in tutta evidenza le pressioni esercitate dalle multinazionali hanno avuto la
meglio sulla "prudenza" ed il governo ha deciso di riprovarci, nonostante la
contrarietà alla riforma sia in tutta evidenza estremamente estesa ed i
commercianti si dichiarino poco propensi a defungere senza combattere.
Leggendo questa notizia non si può evitare di
tornare con la mente alla fine degli anni 80, quando sulle ali del liberismo
progressista, l'invasione degli Iper avvenne anche in Italia. Le proteste ci
furono anche da noi, ma generalmente rimasero circoscritte all'interno delle
singole categorie, isolate le une dalle altre, totalmente estranee al mondo
sindacale e ben lontane dal costituire un moto di popolo.
I sindacati e la politica veicolarono
nell'immaginario collettivo il convincimento che si trattasse semplicemente del
progresso che avanzava, portando in dono modernità e milioni di posti di lavoro
che ci avrebbero resi tutti più felici e più ricchi, ed il popolo italiota come
sempre abboccò all'amo, perché ad un politico e a un sindacalista non si può
dire di no.
In qualche decina di anni, uno dei commerci al
dettaglio fra i più fiorenti e ricchi di peculiarità al mondo fu di fatto
annientato, lasciando senza reddito centinaia di migliaia di famiglie che
vivevano agiatamente del proprio lavoro, per sostituirle con dipendenti spesso
precari che percepiscono salari al limite della sopravvivenza. Mentre l'intero
fatturato del settore che creava ricchezza per milioni di persone e rimetteva
questa ricchezza in circolo, fu accentrato nelle mani di una mezza dozzina di
multinazionali che questa ricchezza la teasurizzano o la trasferiscono altrove,
magari nell'azionariato di una multinazionale degli armamenti.
Fortunatamente almeno il popolo indiano sembra
essere cosciente del fatto che non si tratta proprio di un buon affare.
«Basta con l'Europa dei diktat e dei banchieri»
- rifondazione -
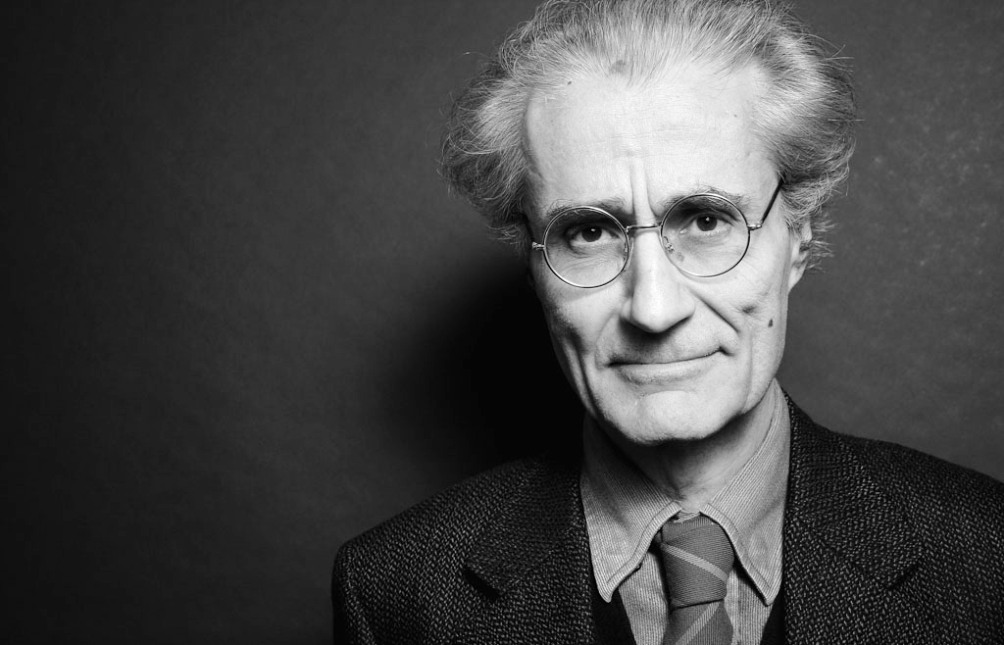
Questo suo libro ha un titolo molto netto, che non lascia spazio a fraintendimenti. Lei sostiene che la costruzione dell'Europa è stata una forma di commissariamento progressivo? Parla di gangsterismo bancario?
Si potrebbe dire che la questione riguarda sia gli storici sia gli economisti. L'Europa non ha una storia unitaria, a parte l'impero romano. Storicamente, è un concetto astratto dei cui confini si discute ancora oggi. Essa dal Cinquecento in avanti è il continente che ha dato l'assalto al mondo creando gli imperi coloniali, come sostiene Toynbee, uno dei maggiori storici del novecento. L'Europa ha aggredito il mondo. Dopodiché la storia del novecento ha visto due volte l'Europa dividersi su fronti contrapposti che ci hanno portato alla catastrofe. Poi, di colpo, essa è diventata buona, ha professato la fratellanza universale e l'unione politica.
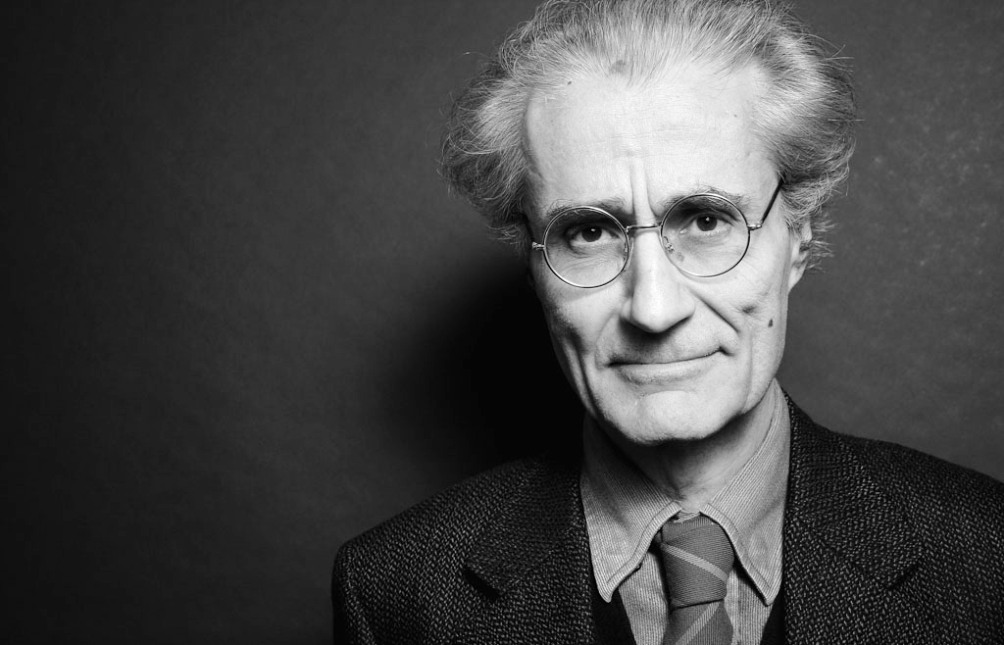
Intervista Luciano Canfora
di Paolo Valentini
di Paolo Valentini
Ce lo chiede l'Europa. Quante volte abbiamo sentito questa frase rintronare le nostre orecchie? Quante volte i media ci hanno riportato alla cruda realtà immobile dei tempi moderni, al diktat incontrovertibile che da Bruxelles, scivolando astioso verso le Alpi e infrangendosi violento e impietoso su Roma e il suo palazzo, è entrato nelle case di tutti gli italiani. Ce lo chiede l'Europa e tutto smette di essere complesso. Tutto diventa unilaterale. Sul tema, purtroppo, la sinistra esprime posizioni subalterne.
Luciano Canfora ha un'idea precisa su questo. Ha da poco pubblicato un libro per Laterza (È l’Europa che ce lo chiede. Falso!) in cui analizza la condizione attuale, smascherando senza pietà le trappole e i luoghi comuni che buona parte della classe politica, anche quella di sinistra, continua a ripetere fino allo sfinimento.
Luciano Canfora ha un'idea precisa su questo. Ha da poco pubblicato un libro per Laterza (È l’Europa che ce lo chiede. Falso!) in cui analizza la condizione attuale, smascherando senza pietà le trappole e i luoghi comuni che buona parte della classe politica, anche quella di sinistra, continua a ripetere fino allo sfinimento.
Questo suo libro ha un titolo molto netto, che non lascia spazio a fraintendimenti. Lei sostiene che la costruzione dell'Europa è stata una forma di commissariamento progressivo? Parla di gangsterismo bancario?
Si potrebbe dire che la questione riguarda sia gli storici sia gli economisti. L'Europa non ha una storia unitaria, a parte l'impero romano. Storicamente, è un concetto astratto dei cui confini si discute ancora oggi. Essa dal Cinquecento in avanti è il continente che ha dato l'assalto al mondo creando gli imperi coloniali, come sostiene Toynbee, uno dei maggiori storici del novecento. L'Europa ha aggredito il mondo. Dopodiché la storia del novecento ha visto due volte l'Europa dividersi su fronti contrapposti che ci hanno portato alla catastrofe. Poi, di colpo, essa è diventata buona, ha professato la fratellanza universale e l'unione politica.
Una ricerca di redenzione?
Si anche se tardiva, direi. Dal punto di vista economico, invece, è un agglomerato di Stati con la Germania al centro. Dopo poco più di sessanta anni la Germania può dirsi la vera vincitrice del secondo conflitto mondiale.
Si anche se tardiva, direi. Dal punto di vista economico, invece, è un agglomerato di Stati con la Germania al centro. Dopo poco più di sessanta anni la Germania può dirsi la vera vincitrice del secondo conflitto mondiale.
Come interagisce la sinistra in questo scenario?
Quando cominciarono i progetti di unificazione europea i confini erano piccolissimi, venivano dettati dalla guerra fredda. Questa è l'Europa di Carlomagno. Allora la sinistra rifiutò quel tipo di idea. La vera idea di Europa era quella di Mazzini. Ma questa non somiglia affatto a quella di Mazzini. Sono troppo piccoli i confini e le ambizioni. Si intuì subito che le economie più forti avrebbero avuto la meglio. Questa è un'Europa costruita per le ambizioni della germania, che impone agli altri delle condizioni proibitive.
Quando cominciarono i progetti di unificazione europea i confini erano piccolissimi, venivano dettati dalla guerra fredda. Questa è l'Europa di Carlomagno. Allora la sinistra rifiutò quel tipo di idea. La vera idea di Europa era quella di Mazzini. Ma questa non somiglia affatto a quella di Mazzini. Sono troppo piccoli i confini e le ambizioni. Si intuì subito che le economie più forti avrebbero avuto la meglio. Questa è un'Europa costruita per le ambizioni della germania, che impone agli altri delle condizioni proibitive.
Lei parla di europeicità come una forma di ideologia? La sinistra ha contribuito a questa costruzione?
Ciò che è sempre più manifesto a sinistra è il fatto che essa abbia perso ogni altro riferimento culturale. Ha svuotato la sua storia. Una volta si diceva Marx, Lenin, Stalin, Mao Tzetung. Oggi è rimasto solo Bobbio. E pure lui diceva che destra e sinistra sono diversi. Ma pure questo concetto è stato messo da parte in nome della coesione. L'europeismo è un'ideologia che non appartiene alla sinistra, che era internazionalista.
Ciò che è sempre più manifesto a sinistra è il fatto che essa abbia perso ogni altro riferimento culturale. Ha svuotato la sua storia. Una volta si diceva Marx, Lenin, Stalin, Mao Tzetung. Oggi è rimasto solo Bobbio. E pure lui diceva che destra e sinistra sono diversi. Ma pure questo concetto è stato messo da parte in nome della coesione. L'europeismo è un'ideologia che non appartiene alla sinistra, che era internazionalista.
La critica che lei fa ci interroga su un’altra questione: che cos'è la democrazia oggi?
Lei parla di crisi drammatica dei sistemi rappresentativi. Come se ne esce? I poteri decisionali vengono delegati a delle istituzioni non elettive dislocate geograficamente lontane. Ai parlamenti nazionali rimane ben poco da decidere. Giocano a fare le leggi elettorali più lambiccate e più contorte possibili. C'è una forma surrettizia di parlamentarismo che però non produce quasi nulla.
Lei parla di crisi drammatica dei sistemi rappresentativi. Come se ne esce? I poteri decisionali vengono delegati a delle istituzioni non elettive dislocate geograficamente lontane. Ai parlamenti nazionali rimane ben poco da decidere. Giocano a fare le leggi elettorali più lambiccate e più contorte possibili. C'è una forma surrettizia di parlamentarismo che però non produce quasi nulla.
L'Europa è usata per lo più per imporre scelte impopolari che nessun politico si prende la responsabilità di effettuare. Ma l'Europa, in passato, ci ha chiesto anche di adeguare i salari alla media europea, di avere leggi che riconoscano molti diritti civili ancora peregrini in Italia. Il salario minimo non esiste mentre in molti paesi si. Insomma usano solo quello che ci conviene?
Proponiamo a Marchionne di aumentare il salario come quello dei cittadini tedeschi. Io sottoscriverei e diventerei un europeista convinto. Il problema è che questa Europa per come è stata costruita è una gabbia d'acciaio. È disumano pensare che gli impiegati greci debbano essere licenziati per risanare un bilancio.
Proponiamo a Marchionne di aumentare il salario come quello dei cittadini tedeschi. Io sottoscriverei e diventerei un europeista convinto. Il problema è che questa Europa per come è stata costruita è una gabbia d'acciaio. È disumano pensare che gli impiegati greci debbano essere licenziati per risanare un bilancio.
So che è un argomento doloroso per lei. Parlando di sinistra usa la parola “fusinistra ”. C'è un modo per costruire la sinistra del futuro senza essere nostalgici?
Se lo avessimo a portata di mano lo avremmo già sperimentato. Gli storici hanno sempre sbagliato nel prevedere lo sviluppo storico. Ci sono variabili imprevedibili che nel presente non vengono mai contemplate. Potrei fare tantissimi nomi di persone che ci hanno provato, ma sarebbe un cimitero. Il motore, il fuoco della sinistra, il globo incandescente presente nella persona umana è e continua a essere l'aspirazione all'uguaglianza. E la lotta prenderà forme che noi non immaginiamo nemmeno. Marchionne sta dando un contributo in questo senso. Sta esasperando a tal punto le condizioni degli operai che sta mettendo insieme un coagulo di persone unite dagli stessi obiettivi. Sta provocando una reazione collettiva forte.
Se lo avessimo a portata di mano lo avremmo già sperimentato. Gli storici hanno sempre sbagliato nel prevedere lo sviluppo storico. Ci sono variabili imprevedibili che nel presente non vengono mai contemplate. Potrei fare tantissimi nomi di persone che ci hanno provato, ma sarebbe un cimitero. Il motore, il fuoco della sinistra, il globo incandescente presente nella persona umana è e continua a essere l'aspirazione all'uguaglianza. E la lotta prenderà forme che noi non immaginiamo nemmeno. Marchionne sta dando un contributo in questo senso. Sta esasperando a tal punto le condizioni degli operai che sta mettendo insieme un coagulo di persone unite dagli stessi obiettivi. Sta provocando una reazione collettiva forte.
Lei sostiene che il profitto non è l'approdo della storia umana. Quale è l'approdo secondo lei?
Lo disse una volta un pontefice di grande spessore come Wojtyla, in un dialogo intenso insieme a Fidel Castro. L'approdo è nella libertà; che non è affidato a misure empiriche ma a una storia di salvezza. La storia deve essere vissuta come un cammino di libertà.
Lo disse una volta un pontefice di grande spessore come Wojtyla, in un dialogo intenso insieme a Fidel Castro. L'approdo è nella libertà; che non è affidato a misure empiriche ma a una storia di salvezza. La storia deve essere vissuta come un cammino di libertà.
Nonostante tutto, ha ancora dei sogni in mezzo alla catastrofe?
Uno fortissimo: nella società italiana, la scuola che ritorna al primo posto. Ora è una cenerentola bisfrattata da tutti. Il ritorno della scuola al centro della società è una mia grande speranza. La scuola è il luogo dove si apprende, è fondamentale.
Uno fortissimo: nella società italiana, la scuola che ritorna al primo posto. Ora è una cenerentola bisfrattata da tutti. Il ritorno della scuola al centro della società è una mia grande speranza. La scuola è il luogo dove si apprende, è fondamentale.
C'è un personaggio o un'epoca dell'antichità che può riassumere le caratteristiche del tecnico o della tecnofinanza di oggi?
Si. Ce n’è uno su tutti. Marco Licinio Crasso: l'uomo più ricco della Roma repubblicana. Quando gli schiavi, con Spartaco a capo della rivolta, si ribellarono furono dati poteri assoluti per soffocare la rivolta con ogni mezzo.
Si. Ce n’è uno su tutti. Marco Licinio Crasso: l'uomo più ricco della Roma repubblicana. Quando gli schiavi, con Spartaco a capo della rivolta, si ribellarono furono dati poteri assoluti per soffocare la rivolta con ogni mezzo.
Pubblico 20 settembre 2012
Non alineati
- strategic culture -
E’ un dato di fatto, che fin dall’inizio la conferenza
del Movimento dei Non Allineati (NAM), convocata alla fine di agosto a Teheran,
attirasse i titoli dei giornali internazionali. In un’epoca indimenticabile,
l’organizzazione, fondata nel 1961 come alleanza di
120 paesi dal trio carismatico Josip Broz Tito, Jamal
Abdel Nasser e Jawaharlal Nehru, era emersa quale forza influente, in grado di
essere autonoma dalla NATO e dal blocco orientale. Anche se l’adesione al NAM
non implica obblighi formali, i componenti hanno raggiunto un impressionante
livello di coordinamento, resistendo al neocolonialismo e tutelando il loro
diritto a un modello di sviluppo originale; e al NAM si deve il merito di aver
svolto un ruolo apprezzabile facendo moderare agli Stati Uniti le loro
avventure militari nel Sud-Est Asiatico, nonché fornendo un supporto
fondamentale ai movimenti di liberazione in Africa e America Latina.
Restando separati dall’arena del mondo bipolare, i
pilastri del NAM in varia misura hanno aderito all’idea di costruire la società
sulle fondamenta della giustizia e del progresso sociale, condannando il
dettato occidentale e, se necessario, affrontando anche il blocco orientale. I
meccanismi interni del NAM cambiarono in seguito al crollo di quest’ultimo e
con l’avvento della globalizzazione, che ha sostituito l’ordine del giorno
neocoloniale con nuovi imperativi.
In questi giorni, il NAM sembrava diviso, con molti dei
suoi membri:
India, Indonesia, Egitto, Arabia Saudita, Afghanistan,
Iraq, ecc ora saldamente nell’orbita degli Stati Uniti, e altri: Jugoslavia e
Libia, minate e infine distrutte dai leader del mondo globalizzato.
Altri ancora, Romania e Finlandia, ad esempio, decisero
la loro uscita dal NAM, le loro priorità le allontanarono dal programma
dell’alleanza. Da una prospettiva più ampia, il rifiuto del modello di sviluppo
socialista ha innescato la crisi di identità del NAM, spingendo la maggior
parte dei suoi membri alla ricerca di strategie alternative e a passare a forme
diluite di partecipazione all’alleanza. Il NAM continua a operare, tuttavia, ed
indice dei congressi ogni tre anni, ma ha solo l’ombra dell’influenza
internazionale di una volta. La diplomazia statunitense ha frettolosamente
dichiarato estinto il NAM in quanto tale, e l’idea che nel mondo di oggi non ci
sia posto per esso viene sostenuta da molti osservatori del mondo, ma ciò
potrebbe rivelarsi un’esagerazione. La conferenza del NAM a Teheran, ha visto
gli alti rappresentanti di 116 paesi, tra i quali 36 presidenti, vicepresidenti
e primi ministri, e più di 80 ministri degli esteri ed inviati speciali;
indicativo dell’importanza attuale dell’alleanza.
Dimostrandosi in grado di ospitare un evento di tali
proporzioni, Teheran ha in gran parte dissipato il mito statunitense che l’Iran
sia percepito, mondialmente, come un paese canaglia. In realtà, per il momento
Washington deve rendersi conto che i suoi sforzi per avere il sostegno per un
giro di vite contro l’Iran, non ha prodotto alcun risultato, se si considera
che solo una manciata di paesi, oltre la NATO, sosterrebbe la condanna del
controverso programma nucleare iraniano. Al contrario, l’ampio congresso del
NAM ha rimproverato gli Stati Uniti per la loro politica intransigente e
ribadito il diritto dell’Iran a un programma nucleare pacifico, compreso anche
al ciclo di arricchimento completo. E’ giusto dire che il NAM prende una
posizione decisa sulla questione chiave, che da sola ha fatto della conferenza
un evento internazionale culminante. L’Iran, si deve ricordare, è firmatario
del Trattato di non proliferazione e ribadisce l’impegno ad esso in ogni
circostanza opportuna, mentre Israele, che minaccia di bombardare gli impianti
nucleari iraniani, non ha firmato il Trattato, ed è noto che possiede un
arsenale nucleare. Tel Aviv ha recentemente espresso nuove minacce contro
l’Iran, e la cancelliera tedesca Angela Merkel ha esortato gli israeliani a dar
prova di moderazione, ma lo spettacolo non deve far dimenticare che il mondo in
via di sviluppo non gradisce la politica estera degli Stati Uniti, o il loro
desiderio di far valere la propria visione riguardo il programma nucleare
iraniano e altro. Emerge sempre più che, con il dipanarsi del conflitto sul
programma nucleare iraniano, ancora una volta viene dimostrato che gli Stati
Uniti dovrebbero adottare un approccio più sobrio negli affari internazionali,
e almeno prendere coscienza delle allergie pervasive alla loro tendenza
all’unilateralismo e ai ricatti.
Quale democrazia per l'Europa?
di Etienne Balibar - sbilanciamoci -
La crisi europea cambia l'assetto dei poteri, modifica l'equilibrio instabile dei rapporti tra gli stati, e tra il livello nazionale e quello europeo. Le decisioni sull'economia non lasciano spazio ai processi democratici. Ma senza democrazia non c'è Europa
Jürgen Habermas ha parlato alto e chiaro sulla situazione europea e le decisioni che essa esige nell’articolo scritto assieme all’economista Peter Bofinger – membro del Consiglio tedesco dei saggi – e all’ex ministro bavarese Julian Nida-Ruemielin, uscito sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung il 3 agosto scorso (in italiano su Repubblica del 4 agosto) con il titolo “Rifiutiamo una democrazia di facciata”, nel quale prende di mira le allusioni di alcuni membri del governo sulla elezione a suffragio universale di un presidente dell’Europa per legittimare il patto di bilancio europeo.
Nell’essenziale la tesi di Habermas è che la crisi non ha nulla a che vedere con le “colpe’ degli Stati spendaccioni che gli stati “economi” stenterebbero a risanare (in tedesco “Schuld” significa sia “debito” sia ”colpa”). Ha invece tutto a che vedere con l’incapacità degli Stati, messi in concorrenza dagli speculatori, di neutralizzare il gioco dei mercati e a premere per una regolamentazione mondiale della finanza. Per cui non si uscirà dalla crisi se l’Europa non si decide a “varcare il passo” verso l’integrazione politica che permetterebbe insieme di difenderne la moneta e affrontare le politiche di riduzione delle ineguaglianze al proprio interno che è la sua ragione di esistere. Terreno naturale di questa trasformazione è il “nocciolo europeo » (Kerneuropa), cioè l’eurozona più gli Stati che dovrebbero entrarvi (in particolare la Polonia). Ma la condizione sine qua non è una democratizzazione autentica delle istituzioni comunitarie, che Habermas intende essenzialmente come formazione d’una rappresentanza parlamentare dei popoli finalmente effettiva (attraverso un sistema a due livelli che egli distingue dal “federalismo” di tipo tedesco), dotata di poteri di controllo politico a livello continentale, in particolare sulla dimensione e l’utilizzazione delle imposte che sosterrebbero la moneta comune, secondo il principio degli insorti americani: «No taxation without representation!».
Bisogna felicitarsi di questo intervento e non lasciarlo isolato. Esso viene dopo una serie di coraggiose prese di posizione con le quali Habermas ha attaccato “il nuovo nazionalismo della politica tedesca e i pregiudizi unilaterali” che esso copre. E comporta un notevole sforzo per tenere assieme il piano politico, quello economico e quello sociale, come a prefigurare il contributo che l’Europa potrebbe portare a una strategia di uscita dalla crisi su scala mondiale, basata sugli imperativi di una protezione dei diritti sociali (che non significa la loro immutabilità) e di una regolazione dei meccanismi di credito che proliferano “sopra la testa” dell’economia reale. Per ultimo, Habermas afferma senza ambiguità che un’Europa politicamente unificata (la si chiami o no «federale ») non è possibile che a condizione d’una democrazia sostanziale che investa la natura stessa dei suoi poteri e della loro rappresentatività, dunque legittimità. Da parte mia, da tempo sostengo una tesi più radicale (qualcuno dirà più vaga): una Europa politica, senza la quale non c’è che declino e impotenza per le popolazioni del continente, non sarà legittima, e quindi possibile, se non sarà più democratica delle nazioni che la compongono, se non farà un passo avanti rispetto alle loro conquiste storiche in tema di democrazia.
Nell’essenziale la tesi di Habermas è che la crisi non ha nulla a che vedere con le “colpe’ degli Stati spendaccioni che gli stati “economi” stenterebbero a risanare (in tedesco “Schuld” significa sia “debito” sia ”colpa”). Ha invece tutto a che vedere con l’incapacità degli Stati, messi in concorrenza dagli speculatori, di neutralizzare il gioco dei mercati e a premere per una regolamentazione mondiale della finanza. Per cui non si uscirà dalla crisi se l’Europa non si decide a “varcare il passo” verso l’integrazione politica che permetterebbe insieme di difenderne la moneta e affrontare le politiche di riduzione delle ineguaglianze al proprio interno che è la sua ragione di esistere. Terreno naturale di questa trasformazione è il “nocciolo europeo » (Kerneuropa), cioè l’eurozona più gli Stati che dovrebbero entrarvi (in particolare la Polonia). Ma la condizione sine qua non è una democratizzazione autentica delle istituzioni comunitarie, che Habermas intende essenzialmente come formazione d’una rappresentanza parlamentare dei popoli finalmente effettiva (attraverso un sistema a due livelli che egli distingue dal “federalismo” di tipo tedesco), dotata di poteri di controllo politico a livello continentale, in particolare sulla dimensione e l’utilizzazione delle imposte che sosterrebbero la moneta comune, secondo il principio degli insorti americani: «No taxation without representation!».
Bisogna felicitarsi di questo intervento e non lasciarlo isolato. Esso viene dopo una serie di coraggiose prese di posizione con le quali Habermas ha attaccato “il nuovo nazionalismo della politica tedesca e i pregiudizi unilaterali” che esso copre. E comporta un notevole sforzo per tenere assieme il piano politico, quello economico e quello sociale, come a prefigurare il contributo che l’Europa potrebbe portare a una strategia di uscita dalla crisi su scala mondiale, basata sugli imperativi di una protezione dei diritti sociali (che non significa la loro immutabilità) e di una regolazione dei meccanismi di credito che proliferano “sopra la testa” dell’economia reale. Per ultimo, Habermas afferma senza ambiguità che un’Europa politicamente unificata (la si chiami o no «federale ») non è possibile che a condizione d’una democrazia sostanziale che investa la natura stessa dei suoi poteri e della loro rappresentatività, dunque legittimità. Da parte mia, da tempo sostengo una tesi più radicale (qualcuno dirà più vaga): una Europa politica, senza la quale non c’è che declino e impotenza per le popolazioni del continente, non sarà legittima, e quindi possibile, se non sarà più democratica delle nazioni che la compongono, se non farà un passo avanti rispetto alle loro conquiste storiche in tema di democrazia.
Il ruolo della Germania
Sigmar Gabriel, capo del
partito socialdemocratico tedesco, ha invitato il filosofo Jürgen Habermas a
partecipare alla stesura del nuovo programma elettorale per le elezioni del
2014
Il risultato è un contributo,
scritto in collaborazione con il filosofo Nida-Rümelin e l’economista Peter
Bofinger, apparso sulle pagine del Frankfurter Allgemeine Zeitung lo scorso
agosto. Sono due i punti chiave che traspaiono sin dalle prime battute: la
critica alla gestione della crisi da parte del governo tedesco, definita “senza
prospettiva”, e la volontà di passare da una “democrazia di facciata”, lasciata
in balìa dei mercati finanziari, a una reale integrazione politica che sappia
rispettare la promessa del modello sociale europeo e dare all’Europa un peso
adeguato nel concerto politico mondiale, a cui le singole entità nazionali
dovrebbero altrimenti rinunciare.
La crisi ha origini ben
precise che il governo di Berlino non sembra aver individuato, affermano i tre
accademici. L’euro rimane una valuta stabile e il debito europeo complessivo è
minore di quello giapponese e americano. La crisi è causata da un mancato
sistema di protezione a livello comunitario per quei paesi con elevato debito
pubblico che faticano a rifinanziarsi sul mercato a causa degli elevati tassi
di interesse. A dispetto degli impegni presi con i programmi di salvataggio il
governo tedesco non ha avuto il coraggio di affrontare quei problemi
strutturali di governance economica che affliggono l’Unione monetaria, portando
la Grecia sull’orlo del fallimento e Italia, Spagna e Portogallo in grave
recessione. Le misure di austerità imposte ai paesi in crisi per accedere al
fondo di salvataggio hanno solamente aggravato le già deboli economie
nazionali. Una corretta strategia anticrisi prevede invece risposte sistemiche
a problemi sistemici. Occorre quindi che una grande potenza economica come
l’Eurozona assuma il ruolo che le compete con un consolidamento del processo di
integrazione verso un sempre maggiore coordinamento delle politiche fiscali, in
modo da ridurre gli squilibri finanziari tra gli stati membri, invece di
lasciare tale compito a misure di recupero temporanee che minano la solidarietà
tra le popolazioni.
Mai come ora torna di
attualità lo slogan della lotta per l’indipendenza americana, No taxation
without representation, aggiungono i tre studiosi. Occorrono istituzioni che
garantiscano che il legislatore democraticamente eletto sia in grado di
decidere delle politiche fiscali europee, tanto dell’imposizione dei tributi
quanto della loro ripartizione. Il governo tedesco, in quanto maggior
contribuente, dovrebbe inoltre guidare l’iniziativa per un processo costituente
europeo che passi attraverso misure di legittimazione popolare. Solo una
risposta positiva a tale quesito potrà legittimare l’utilizzo di strumenti
economici adeguati a restituire ai popoli d’Europa la sovranità sottratta dai
mercati finanziari. Tali cambiamenti saranno i fondamenti di un nuovo nucleo
monetario europeo, aperto a nuovi stati come la Polonia, tuttavia non orientato
al modello federalista.
La crisi economica ha
risvegliato l’interesse delle grandi masse. “È stata la prima volta nella
storia del capitalismo che una crisi causata dalle banche viene pagata dai
contribuenti” tuonano le pagine del Frankfurter Allgemeine. È il momento,
concludono i tre professori, di una discussione aperta e di ampio respiro sul
ruolo dell’Europa nel nuovo corso della storia mondiale.
Occupy creativa sfida Wall Street, 160 arresti e caccia al giornalista
Fonte: il manifesto | Autore: Marina Catucci
 NEW YORK. «This is how demoracy look like»: questo è ciò a cui assomiglia una democrazia. Così recita uno degli slogan più conosciuti di Occupy Wall Street ed è ciò che gli occupiers cercano di mettere in pratica quando scendono in piazza. Durante la tre giorni di festeggiamenti per il primo compleanno del movimento ci sono stati molti esempi di contestazione creativa, non un unico corteo che sarebbe stato immediatamente circondato e disperso dalla polizia ma tante azioni dirette, tanti flash mob, in giro per tutta la zona di Downtown Manhattan impedendo lo svolgimento regolare della giornata e mostrando a tutto il mondo come una protesta pacifica e non violenta venga comunque percepita come pericolosa.
NEW YORK. «This is how demoracy look like»: questo è ciò a cui assomiglia una democrazia. Così recita uno degli slogan più conosciuti di Occupy Wall Street ed è ciò che gli occupiers cercano di mettere in pratica quando scendono in piazza. Durante la tre giorni di festeggiamenti per il primo compleanno del movimento ci sono stati molti esempi di contestazione creativa, non un unico corteo che sarebbe stato immediatamente circondato e disperso dalla polizia ma tante azioni dirette, tanti flash mob, in giro per tutta la zona di Downtown Manhattan impedendo lo svolgimento regolare della giornata e mostrando a tutto il mondo come una protesta pacifica e non violenta venga comunque percepita come pericolosa.
Questo è meno mediatico, non si vedono 50.000 persone sfilare e delude l'obiettivo delle telecamere delle televisioni main stream ma è l'esempio di un movimento che ha il proprio punto di forza nell'uso creativo dell'intelligenza. A questo si riferiva anche Jello Biafra, che ha partecipato al compleanno di Occupy, rispondendo ad una domanda riguardante la scelta non violenta del movimento
«Ero a Seattle nel '99, è bastato un assalto ad uno starbucks per dare ai media l'opportunità di denigrare una marcia pacifica di migliaia di persone ed alla polizia la scusa per usare lacrimogeni e fare arresti indiscriminati. Bisogna fare molta attenzione. Ciò che il movimento black bloc ha fatto, nel passato aveva un senso, ma poi abbiamo visto cosa è successo a Genova; alla polizia è bastato mettersi un passamontagna e fomentare gruppi di persone a compiere atti illegali per i quali poi sono stati arrestati. Ci sono stati casi simili in Texas ed in Ohio, e degli occupiers sono stati arrestati per attività terroristiche. Si fomenta un movimento per farlo diventare violento e poi lo si reprime. Questo si chiama intrappolarlo. Bisogna essere furbi e questo vuol dire che se anche ci piace il rumore dei vetri che si rompono è necessario essere non violenti».
E non violenta è stata la giornata di lunedì, almeno nelle intenzioni degli Occupiers. La giornata doveva cominciare impedendo a Wall Street di aprire le transazioni, questo ha portato a chiudere ogni accesso allo Stock Exchange, multiple file di transenne, polizia a cavallo, posti di blocco ad ogni angolo, e di fatto questo, più che le azioni di Occupy, ha reso difficile lo svolgersi normale della giornata lavorativa. Gli occupiers vestiti elegantemente, mimetizzati da broker della finanza, si recavano ai posti di blocco per passare e alla richiesta di un documento che provasse la loro residenza in quell'area o il loro impiego nella zona di Wall Street, rispondevano cercando a lungo nelle tasche, nella borsa, perdendo tempo, creando file lunghissime dietro di loro.
Questo ha innervosito la polizia più di qualsiasi vetrina rotta ed il risultato sono stati centinaia di fermi e 160 arresti, diversi giornalisti tra cui il giornalista economico Mark Provost, l'illustratore Molly Crabapple ed il radiofonico John Knefel. Le motivazioni per cui i giornalisti vengono arrestati non sono mai chiare, ciò che è chiaro è che sono un target della Nypd.
Sono proprio i giornalisti indipendenti e più di tutto i citizen journalist ad essere nel mirino e sono gli stessi soggetti che hanno collaborato a rendere visibile Ows. Ogni volta che i media mainstrean dichiarano il movimento morto, marginale, ci sono almeno 10 livestreamer a mostrare una piazza viva e produttiva.
Comprendere Occupy richiede uno sforzo, non è simile ai movimenti precedenti, è caratterizzato dall'internazionalismo, da competenze tecniche superiori a quelle della loro controparte, da ideologia e dalla sua prassi pragmatica. Quando sembra silente in realtà è quando sta lavorando con più forza, costruendo alternative al sistema in cui abitiamo nel mondo occidentale. Richiede uno sforzo farsene un'idea e non usare chiavi di lettura preconfezionate, richiede uno sforzo credere che il famoso mondo diverso possibile possa essere realizzato e c'è gente che lo fa quotidianamente; ogni tanto va in piazza e si mostra ai media ma non è quella la parte più importante del suo lavoro, come spesso accade la parte più importante è quella invisibile.
 NEW YORK. «This is how demoracy look like»: questo è ciò a cui assomiglia una democrazia. Così recita uno degli slogan più conosciuti di Occupy Wall Street ed è ciò che gli occupiers cercano di mettere in pratica quando scendono in piazza. Durante la tre giorni di festeggiamenti per il primo compleanno del movimento ci sono stati molti esempi di contestazione creativa, non un unico corteo che sarebbe stato immediatamente circondato e disperso dalla polizia ma tante azioni dirette, tanti flash mob, in giro per tutta la zona di Downtown Manhattan impedendo lo svolgimento regolare della giornata e mostrando a tutto il mondo come una protesta pacifica e non violenta venga comunque percepita come pericolosa.
NEW YORK. «This is how demoracy look like»: questo è ciò a cui assomiglia una democrazia. Così recita uno degli slogan più conosciuti di Occupy Wall Street ed è ciò che gli occupiers cercano di mettere in pratica quando scendono in piazza. Durante la tre giorni di festeggiamenti per il primo compleanno del movimento ci sono stati molti esempi di contestazione creativa, non un unico corteo che sarebbe stato immediatamente circondato e disperso dalla polizia ma tante azioni dirette, tanti flash mob, in giro per tutta la zona di Downtown Manhattan impedendo lo svolgimento regolare della giornata e mostrando a tutto il mondo come una protesta pacifica e non violenta venga comunque percepita come pericolosa. Questo è meno mediatico, non si vedono 50.000 persone sfilare e delude l'obiettivo delle telecamere delle televisioni main stream ma è l'esempio di un movimento che ha il proprio punto di forza nell'uso creativo dell'intelligenza. A questo si riferiva anche Jello Biafra, che ha partecipato al compleanno di Occupy, rispondendo ad una domanda riguardante la scelta non violenta del movimento
«Ero a Seattle nel '99, è bastato un assalto ad uno starbucks per dare ai media l'opportunità di denigrare una marcia pacifica di migliaia di persone ed alla polizia la scusa per usare lacrimogeni e fare arresti indiscriminati. Bisogna fare molta attenzione. Ciò che il movimento black bloc ha fatto, nel passato aveva un senso, ma poi abbiamo visto cosa è successo a Genova; alla polizia è bastato mettersi un passamontagna e fomentare gruppi di persone a compiere atti illegali per i quali poi sono stati arrestati. Ci sono stati casi simili in Texas ed in Ohio, e degli occupiers sono stati arrestati per attività terroristiche. Si fomenta un movimento per farlo diventare violento e poi lo si reprime. Questo si chiama intrappolarlo. Bisogna essere furbi e questo vuol dire che se anche ci piace il rumore dei vetri che si rompono è necessario essere non violenti».
E non violenta è stata la giornata di lunedì, almeno nelle intenzioni degli Occupiers. La giornata doveva cominciare impedendo a Wall Street di aprire le transazioni, questo ha portato a chiudere ogni accesso allo Stock Exchange, multiple file di transenne, polizia a cavallo, posti di blocco ad ogni angolo, e di fatto questo, più che le azioni di Occupy, ha reso difficile lo svolgersi normale della giornata lavorativa. Gli occupiers vestiti elegantemente, mimetizzati da broker della finanza, si recavano ai posti di blocco per passare e alla richiesta di un documento che provasse la loro residenza in quell'area o il loro impiego nella zona di Wall Street, rispondevano cercando a lungo nelle tasche, nella borsa, perdendo tempo, creando file lunghissime dietro di loro.
Questo ha innervosito la polizia più di qualsiasi vetrina rotta ed il risultato sono stati centinaia di fermi e 160 arresti, diversi giornalisti tra cui il giornalista economico Mark Provost, l'illustratore Molly Crabapple ed il radiofonico John Knefel. Le motivazioni per cui i giornalisti vengono arrestati non sono mai chiare, ciò che è chiaro è che sono un target della Nypd.
Sono proprio i giornalisti indipendenti e più di tutto i citizen journalist ad essere nel mirino e sono gli stessi soggetti che hanno collaborato a rendere visibile Ows. Ogni volta che i media mainstrean dichiarano il movimento morto, marginale, ci sono almeno 10 livestreamer a mostrare una piazza viva e produttiva.
Comprendere Occupy richiede uno sforzo, non è simile ai movimenti precedenti, è caratterizzato dall'internazionalismo, da competenze tecniche superiori a quelle della loro controparte, da ideologia e dalla sua prassi pragmatica. Quando sembra silente in realtà è quando sta lavorando con più forza, costruendo alternative al sistema in cui abitiamo nel mondo occidentale. Richiede uno sforzo farsene un'idea e non usare chiavi di lettura preconfezionate, richiede uno sforzo credere che il famoso mondo diverso possibile possa essere realizzato e c'è gente che lo fa quotidianamente; ogni tanto va in piazza e si mostra ai media ma non è quella la parte più importante del suo lavoro, come spesso accade la parte più importante è quella invisibile.
mercoledì 19 settembre 2012
Santiago Carrillo
Addio a Santiago Carrillo


La Spagna e tutti gli antifascisti sono in lutto per la morte avvenuta ieri di Santiago Carrillo, storico ex dirigente del PCE diventato un’icona della resistenza contro la dittatura di Franco. E’ morto ieri all’età di 97 anni nella sua casa di Madrid, e sono in molti a piangere la sua scomparsa. Carrillo era considerato uno degli artefici della transizione iberica alla democrazia, uomo straordinario che ha vissuto per oltre 38 anni in esilio dopo la guerra civile persa nel 1939. Tornare in Spagna infatti avrebbe significato la morte dal momento che la dittatura di Franco non gli avrebbe mai perdonato le sue simpatie comuniste e repubblicane.
Carrillo negli ultimi mesi aveva fatto su e giù dall’ospedale, l’ultima volta a luglio, ma le sue condizioni di salute ormai si erano deteriorate. Nato nelle Asturie, regione povera nel nord della Spagna, il 18 gennaio del 1915, a soli 13 anni Carrillo aveva già cominciato la sua attività politica presso i Giovani Socialisti.
Durante la Guerra Civile spagnola Carrillo svolse il ruolo di delegato all’ordine pubblico a Madrid e, nel 1939, al fine della guerra, cominciò un lungo esilio che lo avrebbe portato in Urss, Argentina, Messico, Algeria e Francia. Sarebbe riuscito a tornare in patria clandestinamente solo nel 1976, un anno prima che venisse legalizzato il PCE, al quale si era iscritto sin dal lontano 1936. Fu eletto infine deputato proprio per i comunisti iberici nel 1977 e venne eletto nelle prime elezioni dell’era democratica, per poi essere anche rieletto nel 1982. Dopo aver abbandonato il PCE e la vita politica nel 1985, Carrillo decise di dedicare i suoi ultimi anni a scrivere libri e articoli, e a tenere conferenze. Carrilllo visse in prima persona il tentativo di golpe del 1981, e fu uno dei tre politici che rimase al suo posto assieme al vicepresidente Suarez e al generale Mellado, disobbediendo così agli ordini del golpista Antonio Tejero Molina. L’attuale segretario del PCE, José Luis Centella, ha salutato la sua morte ricordandolo come un dirigente storico e indimenticato. Adios Carrillo, un uomo straordinario che ci lascia dopo aver dato tutto quello che poteva per il suo Paese.
tribunodelpopolo.com
Quantitative Easing o Prestatore di Ultima Istanza?
Prestatore di Ultima Istanza

Il pezzo è interessante perché Münchau ha ragione, ma allo stesso tempo manca il bersaglio. Vale la pena cercare di chiarire perché.
Münchau ha perfettamente ragione nella sua proposizione principale: l’OMTs non ha nulla a che fare con un programma di espansione monetaria (o quantitative easing); e la condizionalità imposta per accedere agli aiuti non ha senso. Una banca centrale che voglia sostenere la crescita dovrebbe fornire liquidità al sistema attraverso operazioni di mercato aperto e tagli dei tassi aggressivi (anche se i margini per farlo sono esigui).
Münchau manca il bersaglio, tuttavia, quando si lamenta che l’OMTs sarà inefficace perché i governi non lo utilizzeranno. Egli sembra confondere il ruolo di prestatore di ultima istanza e il ruolo di stabilizzazione macroeconomica della politica monetaria. I due ruoli possono essere legati, ma rimangono distinti.
Il compito di un prestatore di ultima istanza è quello di assicurare il debito (in questo caso il debito pubblico), al fine di convincere i mercati sulla solvibilità dei governi, e quindi di disinnescare la speculazione. La banca centrale si impegna ad acquistare titoli di Stato in quantità illimitate, in modo da rassicurare i mercati che ci sia sempre un acquirente per il debito che detengono in portafoglio. Il successo di un prestatore di ultima istanza quindi non è misurato dal numero di paesi (o banche) che hanno bisogno di farvi ricorso, ma piuttosto dal contrario. Se nessun paese ha bisogno di aiuto della BCE, questo significa che il suo ruolo di assicuratore è credibile. L’efficacia di un prestatore di ultima istanza è misurata dai tassi di interesse di mercato (che sono effettivamente diminuiti dopo l’annuncio di Mario Draghi).
Credo che il problema dell’OMTs sia la condizionalità, ma non perché potrebbe spingere i governi a non chiedere aiuto; ripeto che questo sarebbe il segno che la BCE è efficace. La condizionalità è un problema perché porterebbe ad ulteriore austerità e, quindi, ostacolerebbe la crescita (e la sostenibilità del debito a lungo termine).
Per valutare il successo di una banca centrale nel sostenere la crescita, invece, occorre valutare se l’incremento di liquidità fornita ai mercati risulta in condizioni creditizie migliori, e se questo a sua volta spinge al rialzo la spesa privata. Sono d’accordo con Münchau che la BCE non fa abbastanza per sostenere la crescita della zona euro, e che questo sia censurabile (per rimanere ben educati). Ma resta importante distinguere chiaramente tra i diversi compiti di una banca centrale, anche al fine di essere più efficaci nella critica.
Vale la pena peraltro di notare che oggi, per rilanciare l’economia, dovrebbe essere preferita la politica fiscale, visto l’economia europea rimane in una trappola della liquidità e il meccanismo di trasmissione della politica monetaria è non è perfettamente funzionante. Tuttavia, Paul Krugman spiega piuttosto bene perché, anche in situazioni di trappola della liquidità, un’espansione monetaria potrebbe funzionare.
Sarebbe auspicabile che, come la Fed, la BCE assumesse sia il ruolo di prestatore di ultima istanza che il compito di sostenere la crescita attraverso un’espansione monetaria. Ma purtroppo, oggi questo non è all’ordine del giorno. La BCE non sostiene la crescita della zona euro, in parte perché il suo mandato è limitato al solo obiettivo di inflazione (e ho già detto molto tempo fa che questo è semplicemente pazzesco). Ma, ancora più importante, perché non vuole farlo. La BCE e il suo Presidente sono intrappolati nell’ortodossia che soffoca l’Europa dagli anni ottanta. L’unica soluzione che propongono sono le riforme strutturali, e ancora le riforme strutturali.
Quando questo cambierà, saremo infine di fronte alla vera rivoluzione nella zona euro.
(*) OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques – centre de recherche en économie de Sciences Po, Paris

di Francesco Saraceno
Wolfgang Münchau ha scritto un interessante articolo sul Financial Times di ieri. Per riassumere, Münchau sostiene che vi sia la possibilità che il nuovo programma OMTs [Outright Monetary Transactions, acquisto "illimitato" di titoli del debito pubblico a breve scadenza (fino a tre anni) dei paesi periferici, ndr] lanciato dalla Banca centrale europea non venga mai utilizzato, perché i governi dei paesi interessati non saranno incentivati a mettersi sotto la tutela della Troika. L’OMTs rischia quindi di essere inefficace nel rilanciare l’economia. Egli sostiene quindi che la BCE avrebbe dovuto fare come la Fed, e annunciare un programma incondizionato di acquisto di obbligazioni (private e pubbliche).
Il pezzo è interessante perché Münchau ha ragione, ma allo stesso tempo manca il bersaglio. Vale la pena cercare di chiarire perché.
Münchau ha perfettamente ragione nella sua proposizione principale: l’OMTs non ha nulla a che fare con un programma di espansione monetaria (o quantitative easing); e la condizionalità imposta per accedere agli aiuti non ha senso. Una banca centrale che voglia sostenere la crescita dovrebbe fornire liquidità al sistema attraverso operazioni di mercato aperto e tagli dei tassi aggressivi (anche se i margini per farlo sono esigui).
Münchau manca il bersaglio, tuttavia, quando si lamenta che l’OMTs sarà inefficace perché i governi non lo utilizzeranno. Egli sembra confondere il ruolo di prestatore di ultima istanza e il ruolo di stabilizzazione macroeconomica della politica monetaria. I due ruoli possono essere legati, ma rimangono distinti.
Il compito di un prestatore di ultima istanza è quello di assicurare il debito (in questo caso il debito pubblico), al fine di convincere i mercati sulla solvibilità dei governi, e quindi di disinnescare la speculazione. La banca centrale si impegna ad acquistare titoli di Stato in quantità illimitate, in modo da rassicurare i mercati che ci sia sempre un acquirente per il debito che detengono in portafoglio. Il successo di un prestatore di ultima istanza quindi non è misurato dal numero di paesi (o banche) che hanno bisogno di farvi ricorso, ma piuttosto dal contrario. Se nessun paese ha bisogno di aiuto della BCE, questo significa che il suo ruolo di assicuratore è credibile. L’efficacia di un prestatore di ultima istanza è misurata dai tassi di interesse di mercato (che sono effettivamente diminuiti dopo l’annuncio di Mario Draghi).
Credo che il problema dell’OMTs sia la condizionalità, ma non perché potrebbe spingere i governi a non chiedere aiuto; ripeto che questo sarebbe il segno che la BCE è efficace. La condizionalità è un problema perché porterebbe ad ulteriore austerità e, quindi, ostacolerebbe la crescita (e la sostenibilità del debito a lungo termine).
Per valutare il successo di una banca centrale nel sostenere la crescita, invece, occorre valutare se l’incremento di liquidità fornita ai mercati risulta in condizioni creditizie migliori, e se questo a sua volta spinge al rialzo la spesa privata. Sono d’accordo con Münchau che la BCE non fa abbastanza per sostenere la crescita della zona euro, e che questo sia censurabile (per rimanere ben educati). Ma resta importante distinguere chiaramente tra i diversi compiti di una banca centrale, anche al fine di essere più efficaci nella critica.
Vale la pena peraltro di notare che oggi, per rilanciare l’economia, dovrebbe essere preferita la politica fiscale, visto l’economia europea rimane in una trappola della liquidità e il meccanismo di trasmissione della politica monetaria è non è perfettamente funzionante. Tuttavia, Paul Krugman spiega piuttosto bene perché, anche in situazioni di trappola della liquidità, un’espansione monetaria potrebbe funzionare.
Sarebbe auspicabile che, come la Fed, la BCE assumesse sia il ruolo di prestatore di ultima istanza che il compito di sostenere la crescita attraverso un’espansione monetaria. Ma purtroppo, oggi questo non è all’ordine del giorno. La BCE non sostiene la crescita della zona euro, in parte perché il suo mandato è limitato al solo obiettivo di inflazione (e ho già detto molto tempo fa che questo è semplicemente pazzesco). Ma, ancora più importante, perché non vuole farlo. La BCE e il suo Presidente sono intrappolati nell’ortodossia che soffoca l’Europa dagli anni ottanta. L’unica soluzione che propongono sono le riforme strutturali, e ancora le riforme strutturali.
Quando questo cambierà, saremo infine di fronte alla vera rivoluzione nella zona euro.
(*) OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques – centre de recherche en économie de Sciences Po, Paris
keynesblog.com
Dal 15 al 21 ottobre... una settimana per il reddito garantito!
- rifondazione -
 >'; document.write(''); document.write(addy_text75731); document.write('<\/a>'); //-->\n
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
; cosi che tutte le iniziative raccolte possano essere visibili attraverso il sito ufficiale della campagnawww.redditogarantito.it <http://campagnawww.redditogarantito.it/>; . Inoltre, vi chiediamo di fare foto e video delle iniziative da pubblicare e far circolare in rete
>'; document.write(''); document.write(addy_text75731); document.write('<\/a>'); //-->\n
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
; cosi che tutte le iniziative raccolte possano essere visibili attraverso il sito ufficiale della campagnawww.redditogarantito.it <http://campagnawww.redditogarantito.it/>; . Inoltre, vi chiediamo di fare foto e video delle iniziative da pubblicare e far circolare in rete

di redditogarantito.it
Nel giugno scorso un'ampia coalizione di associazioni, reti sociali, partiti, movimenti, comitati, collettivi ha lanciato la campagna per un reddito minimo garantito in Italia. Una campagna nata intorno ad una proposta di legge di iniziativa popolare che intende istituire anche nel nostro Paese una garanzia per il reddito per coloro che sono precari, disoccupati e inoccupati, oggi soprattutto giovani, donne e Working Poor.
Una campagna che vuole rilanciare quelle fondamenta di un modello sociale europeo che le politiche neoliberiste hanno minato, per un Welfare universale che garantisca misure di sostegno alle persone, per rilanciare politiche di redistribuzione delle ricchezze e mettere al centro del dibattito politico le garanzie, i diritti, le libertà di scelta delle persone.
Una campagna che vuole rilanciare quelle fondamenta di un modello sociale europeo che le politiche neoliberiste hanno minato, per un Welfare universale che garantisca misure di sostegno alle persone, per rilanciare politiche di redistribuzione delle ricchezze e mettere al centro del dibattito politico le garanzie, i diritti, le libertà di scelta delle persone.
La proposta di legge di iniziativa popolare per il reddito minimo garantito in Italia lanciata a giugno (e che continua a raccogliere adesioni e sostegno) terminerà a dicembre: l'obiettivo minimo è raggiungere almeno 50 mila, ma si può fare di più! Raccogliere migliaia e migliaia di firme significa dare un segnale politico e sociale importantissimo, sia alla società che alla politica italiana. Ma non solo: questa campagna rende possibile l'opportunità di discutere di reddito e diritti, di parlare alla società, nelle strade, piazze, università, luoghi di lavoro, con i giovani, le donne, i precari, gli studenti. In poche parole, una grande opportunità di comunicazione e iniziativa sociale che dia maggior forza ad una nuova stagione di diritti a partire dal reddito garantito.
Per questo, oltre le tante iniziative già realizzate durante questi mesi e promosse dai partecipanti alla campagna, riteniamo importante proporre la realizzazione di un evento comune: "LA SETTIMANA PER IL REDDITO GARANTITO" dal 15 al 21 ottobre. Una settimana comune, per tutti coloro che partecipano o vogliono partecipare alla campagna e alla raccolta firme, in cui realizzare:
concerti, dibattiti, spettacoli teatrali, volantinaggi, reading, presentazioni di libri, seminari, dance hall, cineforum, performance e quant'altro possa essere utile a comunicare, approfondire, rendere visibile il tema del reddito garantito nei mercati rionali, nelle sedi delle associazioni, nelle piazze delle città, librerie, centri sociali, fuori i supermercati, i posti di lavoro, le università, i luoghi di ritrovo.
Una SETTIMANA PER IL REDDITO GARANTITO dove tutti insieme, a carattere locale ed in forma autonoma, si dia vita ad una grande comunicazione sociale, si raccolgano migliaia di firme, si dia corpo alla fantasia e alla creatività, si costruisca un grande evento comunicativo in cui il tema del reddito garantito attraversi la penisola. Si possono realizzare iniziative per la settimana intera o anche solo un giorno, l'importante è che in quella settimana in ogni dove si parli di reddito, Welfare, diritti e si raccolgano firme.
Proponiamo dunque di dare vita ad una settimana di iniziative nella vostra città, di comunicarne il programma a redditominimogarantito@sxmail.it Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per questo, oltre le tante iniziative già realizzate durante questi mesi e promosse dai partecipanti alla campagna, riteniamo importante proporre la realizzazione di un evento comune: "LA SETTIMANA PER IL REDDITO GARANTITO" dal 15 al 21 ottobre. Una settimana comune, per tutti coloro che partecipano o vogliono partecipare alla campagna e alla raccolta firme, in cui realizzare:
concerti, dibattiti, spettacoli teatrali, volantinaggi, reading, presentazioni di libri, seminari, dance hall, cineforum, performance e quant'altro possa essere utile a comunicare, approfondire, rendere visibile il tema del reddito garantito nei mercati rionali, nelle sedi delle associazioni, nelle piazze delle città, librerie, centri sociali, fuori i supermercati, i posti di lavoro, le università, i luoghi di ritrovo.
Una SETTIMANA PER IL REDDITO GARANTITO dove tutti insieme, a carattere locale ed in forma autonoma, si dia vita ad una grande comunicazione sociale, si raccolgano migliaia di firme, si dia corpo alla fantasia e alla creatività, si costruisca un grande evento comunicativo in cui il tema del reddito garantito attraversi la penisola. Si possono realizzare iniziative per la settimana intera o anche solo un giorno, l'importante è che in quella settimana in ogni dove si parli di reddito, Welfare, diritti e si raccolgano firme.
Proponiamo dunque di dare vita ad una settimana di iniziative nella vostra città, di comunicarne il programma a redditominimogarantito@sxmail.it Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Il 15 settembre, da tutta Europa, i cittadini del continente protesteranno contro la nuova Gestapo.
Ecco il chinotto che vogliono farci bere. - sergiodicorimodigliani -
di Sergio Di Cori Modigliani
Si
chiama “Chinotto” ed è la bibita che la finanza oligarchica planetaria, con la
totale complicità della cupola mediatica italiota, intende farci bere, anzi
ingoiare a forza. Che ci piaccia o non ci piaccia.
Com’è
noto, il chinotto è una bibita nostrana, siamo l’unico paese a produrla (mia
madre l’amava tanto, a me personalmente non piace) ma in questo caso parliamo
d’altro.
CHINOTTO
è il nome della caserma nella Regione Veneto che ufficialmente è diventato il
centro strategico e comando generale della superpolizia europea, la nuova
Gestapo friedmaniana.
Intendiamoci,
il tutto ben ordito dal punto di vista legale e istituzionale, perché 34
burocrati europei (nessuno dei quali è stato eletto nei loro rispettivi paesi)
sotto la adorabile e materna protezione del comando generale della Nato in
Europa, nella primavera del 2007, ha “inventato” un super ente poliziesco
extra-istituzionale, che è la fotocopia dello statuto della Gestapo del Terzo
Reich. A questo punto, ogni cittadino italiano, sano di mente, non tifoso,
moderato ma attento, è autorizzato ad avere la giusta reazione di buon Senso
“suvvia, saranno quatro beceroni con ansie militariste, l’Europa è piena di
gente così”.
Anche
io reagirei così.
E
invece si tratta di ben altro, ragione per cui scrivo questo
post.
Quei
34 burocrati hanno fatto le cose per bene.
Hanno
inviato il loro memorandum ai rispettivi ministri della difesa e ministri degli
interni di quattro nazioni dell’Unione Europea, chiedendone la immediata
approvazione (e quindi aggirando il parlamento, in quanto non è stata data
alcuna notifica ai cittadini votanti); una volta ricevute tutte le firme –per
quanto riguarda l’Italia le firme sono state quelle di Giuliano Amato e Arturo
Parisi nel 2007 e poi riconfermate nel 2010 da Roberto Maroni e Ignazio La
Russa- hanno redatto un trattato firmato dagli stati membri considerati quelli
più “a rischio di rivolta” (Italia, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi) con la
“automatica possibilità di estensione a tutti i paesi memberi dell’Unione
Europea”. Dopodichè (avendo cura, grazie alla complicità della cupola mediatica,
che la notizia non venisse diffusa sulla stampa e sulla tivvù mainstream) hanno
provveduto affinchè tale trattato venisse presentato, discusso e approvato nei
singoli parlamenti. Evento che in Italia (così come negli altri quattro paesi
europei) si è regolarmente verificato.
Voi
tutti, cittadini votanti della Repubblica Italiana, avete dato vita alla
costituzione di una organizzazione militare con poteri extra-giudiziali,
extra-istituzionali, con lo specifico obiettivo “di avere pronta una squadra di
reparti speciali militari per affrontare e fronteggiare in qualunque momento
azioni di ribellione sociale tali da essere ritenute pericolose per la tenuta
legale delle singole nazioni”.
L’avete
votata, va da sé, a vostra insaputa.
Nessuno
ve l’ha mai detto.
Nessuno
ve l’ha mai spiegato.
Nessuno
ve l’ha mai raccontato.
Tutto
ciò è avvenuto nel 2010, sotto l’amorevole custodia dell’allora comandante della
Nato in Europa, ammiraglio Di Paola (attuale ministro della Difesa del governo
Monti) e porta il nome di TRATTATO
DI VELSEN.
Quanti
di voi ne hanno mai sentito parlare?
A
quanti di voi è stato detto che il parlamento stava votando l’approvazione di
questo trattato?
A quanrti di voi, sia la fortissima maggioranza politica di allora (PDL, Lega Nord e AN) sia la fortissima opposizione (PD, UDC, IDV e altri) hanno spiegato per esteso, argomentando ed elaborando, il Senso dell’articolo 23 del Trattato di Velsen che il parlamento stava per approvare e che recita così: “ogni membro di tale corpo, non è sottoponibile ad alcun controllo di comunicazione da parte di nessuna forza dell’ordine nazionale; le loro conversazioni non possono legalmente essere intercettate e non sono passibili di nessuna forma di verifica”?
martedì 18 settembre 2012
Peep Show.
Noi e la guerra. Anzi, le guerre - rifondazione -


di Maria R. Calderoni
Noi e la guerra. Anzi, le guerre. Sapete cos'è un peep show? «Il peep show in sostanza è un tipo di erotismo on the spot. Invece di noleggiare o scaricare un film porno, il cliente va in certi locali specializzati, acquista un gettone e assiste, per lo più dietro un vetro, alle evoluzioni sessuali di professionisti, singoli o in coppia».
Ebbene, qualcosa di analogo avviene nel campo delle nostre "guerre moderne", vi era sfuggito? «Ritengo che la copertura mediale delle guerre contemporanee sia strutturalmente simile a un peep show”. Una copertura che «presuppone un pubblico planetario il quale con la sua presenza in diretta, e anzi partecipante, rende possibile la messa in scena della violenza armata.
Ebbene, qualcosa di analogo avviene nel campo delle nostre "guerre moderne", vi era sfuggito? «Ritengo che la copertura mediale delle guerre contemporanee sia strutturalmente simile a un peep show”. Una copertura che «presuppone un pubblico planetario il quale con la sua presenza in diretta, e anzi partecipante, rende possibile la messa in scena della violenza armata.
Insomma un peep show militare globale».
Pressoché con questo incipit "inquietante", Alessandro Dal Lago nel suo nuovo libro - " Carnefici e spettatori. La nostra indifferenza verso la crudeltà ", Cortina, pag. 220, € 13,50 - percorre e illustra la nostra colpevole inerzia e irresponsabilità davanti alle tante guerre che abbiamo guardato ma non "visto". Delle quali siamo stati spettatori, ma al di là del vetro.
Alessandro Dal Lago, professore di Sociologia della comunicazione all'Università di Genova, è un esperto del ramo, da anni si occupa di strategia militare e queste pagine sono insieme specialistiche ed emozionanti.
Tanto per cominciare, dobbiamo riflettere, come Foucault, «sul non detto o il deliberatamente taciuto di quella che si chiama "tradizione occidentale"». Volendo, anche "civiltà occidentale": dal momento che, appunto, «forse per la nostra supposta civiltà», noi saremmo «depositari di un senso della giustizia che va applicato mediante le nostre forze armate».
Quanti secoli ci separano dagli antichi romani? Tanti, ma non abbastanza da renderci troppo "diversi" da loro, su un certo terreno. Nel capitolo intitolato "La crudeltà degli antichi e dei moderni", l'autore descrive, con dovizia di riferimenti storici e letterari, «come si divertivano gli antichi romani»: i supplizi e le uccisioni atroci eseguiti in pubblico per il divertimento della plebe e dell'imperatore; le lotte all'ultimo sangue dei gladiatori ferocemente e grandiosamente allestite nei circhi straripanti di folla entusiasta. Già, anche nei libri di testo si è sempre glissato su «un aspetto della cultura di Roma antica: la ferocia o, meglio, la straordinaria indifferenza per la crudeltà».
Uccidere gli schiavi - considerati "strumenti parlanti" di una società basata sulla schiavitù - doveva sembrare legittimo, fisiologico (persino doveroso): in nome della legalità, della giustizia, della sicurezza e delle esigenze del potere (ci suona stranamente familiare...).
Noi moderni siamo certo diversi; ma, analizzando la nostra moderna, modernissima violenza bellica, si deve dire che ci troviamo di fronte «non già a un processo di incivilimento progressivo, ma a una differenziazione delle strategie di gestione della violenza e della spettacolarizzazione della violenza». Mutatis mutandis.
Molto toccanti i capitoli dedicati alle torture quando l'umanità è già arrivata alla fine del XVIII secolo («torace braccia e cosce gli furon squarciati. Nelle ferite gli fu versato pombo fuso. Lo cosparsero di olio bollente pece infuocata cera e zolfo. La mano gli fu bruciata via...», così per esempio venne torturato e ucciso a Parigi Damiens che aveva attentato alla vita di Luigi XV); alle esecuzioni capitali; alla Prima e Seconda guerra mondiale, quando quella stessa umanità ha già varcato il XX secolo («la massificazione di uomini e materiali, l'estensione dei fronti, la durezza incessante, il coinvolgimento di tutto ciò che è estraneo alla guerra, la terribilità crescente delle armi...»). Quando «nella guerra di trincea svanì qualsiasi idea positiva di progresso». Quando avvenne quello che Dal Lago racconta nel capitolo intitolato "l'incommensurabile". Perché «il Novecento è stato il secolo della guerra. Tutto quello che gli uomini si sono fatti da quando sono comparsi sulla terra, rimpicciolisce davanti ai più di cento milioni di morti del XX secolo, una cifra superiore alle vittime di tutte le guerre precedenti».
Guardiamo ma non "vediamo". «Volgere gli occhi da un'altra parte è oggi l'atteggiamento più diffuso davanti alla guerra». Nel XXI secolo, tra molto altro, l'Occidente ha infatti conquistato anche l'invisibilità" della guerra. «Dal 1991 ad oggi, i Paesi occidentali, Stati Uniti in testa, hanno combattuto in tre continenti (Iraq, Bosnia, Somalia, Serbia, Afghanistan, ancora Iraq, Libia, Pakistan ecc), alla media di una guerra ogni due anni circa». Eppure, nessuno le ha "viste". «Al di là del clamore estemporaneo delle cronache, si direbbe "che non siamo mai in guerra"». Quanto alla voce degli sconfitti, «come sempre, è scomparsa con loro».
Nostre guerre "mai "viste". «Oggi, l'invisibilità delle guerre in cui l'Occidente è coinvolto è arrivata a vertici a dir poco surreali. Le guerre vengono combattute nella massima indifferenza di gran parte delle popolazioni occidentali e rimosse con straordinaria rapidità». E, «mentre da più parti - nel momento in cui sto terminando questo saggio - si parla di un attacco di Israele (e forse degli Stati Uniti) contro l'Iran e alcuni caldeggiano un intervento occidentale contro la Siria, nessuno si ricorda più della guerra aerea della NATO in Libia. Era solo la primavera del 2011 e sembra un secolo fa».
Del resto, ora non le chiamano più nemmeno guerre. Ora le chiamano «interventi di polizia globale», scusate la falsificazione.
Pressoché con questo incipit "inquietante", Alessandro Dal Lago nel suo nuovo libro - " Carnefici e spettatori. La nostra indifferenza verso la crudeltà ", Cortina, pag. 220, € 13,50 - percorre e illustra la nostra colpevole inerzia e irresponsabilità davanti alle tante guerre che abbiamo guardato ma non "visto". Delle quali siamo stati spettatori, ma al di là del vetro.
Alessandro Dal Lago, professore di Sociologia della comunicazione all'Università di Genova, è un esperto del ramo, da anni si occupa di strategia militare e queste pagine sono insieme specialistiche ed emozionanti.
Tanto per cominciare, dobbiamo riflettere, come Foucault, «sul non detto o il deliberatamente taciuto di quella che si chiama "tradizione occidentale"». Volendo, anche "civiltà occidentale": dal momento che, appunto, «forse per la nostra supposta civiltà», noi saremmo «depositari di un senso della giustizia che va applicato mediante le nostre forze armate».
Quanti secoli ci separano dagli antichi romani? Tanti, ma non abbastanza da renderci troppo "diversi" da loro, su un certo terreno. Nel capitolo intitolato "La crudeltà degli antichi e dei moderni", l'autore descrive, con dovizia di riferimenti storici e letterari, «come si divertivano gli antichi romani»: i supplizi e le uccisioni atroci eseguiti in pubblico per il divertimento della plebe e dell'imperatore; le lotte all'ultimo sangue dei gladiatori ferocemente e grandiosamente allestite nei circhi straripanti di folla entusiasta. Già, anche nei libri di testo si è sempre glissato su «un aspetto della cultura di Roma antica: la ferocia o, meglio, la straordinaria indifferenza per la crudeltà».
Uccidere gli schiavi - considerati "strumenti parlanti" di una società basata sulla schiavitù - doveva sembrare legittimo, fisiologico (persino doveroso): in nome della legalità, della giustizia, della sicurezza e delle esigenze del potere (ci suona stranamente familiare...).
Noi moderni siamo certo diversi; ma, analizzando la nostra moderna, modernissima violenza bellica, si deve dire che ci troviamo di fronte «non già a un processo di incivilimento progressivo, ma a una differenziazione delle strategie di gestione della violenza e della spettacolarizzazione della violenza». Mutatis mutandis.
Molto toccanti i capitoli dedicati alle torture quando l'umanità è già arrivata alla fine del XVIII secolo («torace braccia e cosce gli furon squarciati. Nelle ferite gli fu versato pombo fuso. Lo cosparsero di olio bollente pece infuocata cera e zolfo. La mano gli fu bruciata via...», così per esempio venne torturato e ucciso a Parigi Damiens che aveva attentato alla vita di Luigi XV); alle esecuzioni capitali; alla Prima e Seconda guerra mondiale, quando quella stessa umanità ha già varcato il XX secolo («la massificazione di uomini e materiali, l'estensione dei fronti, la durezza incessante, il coinvolgimento di tutto ciò che è estraneo alla guerra, la terribilità crescente delle armi...»). Quando «nella guerra di trincea svanì qualsiasi idea positiva di progresso». Quando avvenne quello che Dal Lago racconta nel capitolo intitolato "l'incommensurabile". Perché «il Novecento è stato il secolo della guerra. Tutto quello che gli uomini si sono fatti da quando sono comparsi sulla terra, rimpicciolisce davanti ai più di cento milioni di morti del XX secolo, una cifra superiore alle vittime di tutte le guerre precedenti».
Guardiamo ma non "vediamo". «Volgere gli occhi da un'altra parte è oggi l'atteggiamento più diffuso davanti alla guerra». Nel XXI secolo, tra molto altro, l'Occidente ha infatti conquistato anche l'invisibilità" della guerra. «Dal 1991 ad oggi, i Paesi occidentali, Stati Uniti in testa, hanno combattuto in tre continenti (Iraq, Bosnia, Somalia, Serbia, Afghanistan, ancora Iraq, Libia, Pakistan ecc), alla media di una guerra ogni due anni circa». Eppure, nessuno le ha "viste". «Al di là del clamore estemporaneo delle cronache, si direbbe "che non siamo mai in guerra"». Quanto alla voce degli sconfitti, «come sempre, è scomparsa con loro».
Nostre guerre "mai "viste". «Oggi, l'invisibilità delle guerre in cui l'Occidente è coinvolto è arrivata a vertici a dir poco surreali. Le guerre vengono combattute nella massima indifferenza di gran parte delle popolazioni occidentali e rimosse con straordinaria rapidità». E, «mentre da più parti - nel momento in cui sto terminando questo saggio - si parla di un attacco di Israele (e forse degli Stati Uniti) contro l'Iran e alcuni caldeggiano un intervento occidentale contro la Siria, nessuno si ricorda più della guerra aerea della NATO in Libia. Era solo la primavera del 2011 e sembra un secolo fa».
Del resto, ora non le chiamano più nemmeno guerre. Ora le chiamano «interventi di polizia globale», scusate la falsificazione.
L’era del consumo collaborativo
Città invisibile* |
Mercati del riuso e del baratto, co-working, car sharing e car pooling, banche del tempo, Gruppi di acquisto solidale, scambio di case per le vacanze, crowdfunding, vendita di servizi piuttosto che di beni. In Spagna e in America latina c’è chi sostiene che queste e altre forme di «consumo collaborativo» (o «economia di collaborazione») siano un fenomeno vario e sempre più diffuso. Che prova a mettere in discussione alcuni dogmi del capitalismo. Pubblichiamo alcuni stralci di un articolo su questi temi segnalato da Madrilonia.org e pubblicato su Consumocolaborativo.com.
 Si è spesso discusso se il consumo collaborativo sia soltanto una reazione alla crisi, come in Argentina nel 2001 (…). In ogni caso, è interessante analizzare i fattori che hanno favorito i settori e il consumo di collaborazione in America latina: la mobilità condivisa, il crowdfunding e i numerosi programmi di sostegno per gli imprenditori.
La mobilità
Si è spesso discusso se il consumo collaborativo sia soltanto una reazione alla crisi, come in Argentina nel 2001 (…). In ogni caso, è interessante analizzare i fattori che hanno favorito i settori e il consumo di collaborazione in America latina: la mobilità condivisa, il crowdfunding e i numerosi programmi di sostegno per gli imprenditori.
La mobilità
 In Cile abbiamo anche ShareTribe (per creare comunità da condividere), Koru (…), Mamaroof (alloggi per studenti), LocalGuiding, Cumplo, TomoClases, Aventones (carpooling), UniPlaces (alloggi per universitari in case private), CrowdPlaces (crowdfuding per spazi urbani), TuCreaz (mercato per artisti), Oja.la (istruzione online), Tu Closet Mi Closet (per lo scambio dell’abbigliamento) e TouristLink (turismo sociale) … e Startup Chilegite (carpooling) (…).
Non male vero? (…). Non abbiamo la sfera di cristallo per sapere cosa accadrà al «consumo di collaborazione» in America latina (e in Spagna), ma siamo in grado di individuare alcuni aspetti importanti. Vedremo iniziative di internazionalizzazione (…). Vedremo le leggi in grado di influenzare l’avanzamento non omogeneo del consumo collaborativo in diversi paesi (…). Vedremo fusioni e acquisizioni come quelle che hanno avuto luogo in Brasile nel campo del crowdfunding. E presto dovremmo vedere più iniziative in settori come l’istruzione (…) e i servizi finanziari (…)
In Cile abbiamo anche ShareTribe (per creare comunità da condividere), Koru (…), Mamaroof (alloggi per studenti), LocalGuiding, Cumplo, TomoClases, Aventones (carpooling), UniPlaces (alloggi per universitari in case private), CrowdPlaces (crowdfuding per spazi urbani), TuCreaz (mercato per artisti), Oja.la (istruzione online), Tu Closet Mi Closet (per lo scambio dell’abbigliamento) e TouristLink (turismo sociale) … e Startup Chilegite (carpooling) (…).
Non male vero? (…). Non abbiamo la sfera di cristallo per sapere cosa accadrà al «consumo di collaborazione» in America latina (e in Spagna), ma siamo in grado di individuare alcuni aspetti importanti. Vedremo iniziative di internazionalizzazione (…). Vedremo le leggi in grado di influenzare l’avanzamento non omogeneo del consumo collaborativo in diversi paesi (…). Vedremo fusioni e acquisizioni come quelle che hanno avuto luogo in Brasile nel campo del crowdfunding. E presto dovremmo vedere più iniziative in settori come l’istruzione (…) e i servizi finanziari (…)
Città invisibile è un piccolo collettivo romano attento ai temi sociali e della decrescita.
 Si è spesso discusso se il consumo collaborativo sia soltanto una reazione alla crisi, come in Argentina nel 2001 (…). In ogni caso, è interessante analizzare i fattori che hanno favorito i settori e il consumo di collaborazione in America latina: la mobilità condivisa, il crowdfunding e i numerosi programmi di sostegno per gli imprenditori.
Si è spesso discusso se il consumo collaborativo sia soltanto una reazione alla crisi, come in Argentina nel 2001 (…). In ogni caso, è interessante analizzare i fattori che hanno favorito i settori e il consumo di collaborazione in America latina: la mobilità condivisa, il crowdfunding e i numerosi programmi di sostegno per gli imprenditori.
In Argentina, la concorrenza è feroce tra Vayamos juntos, Vamos mejor, SincroPool (carpooling orientato a organizzazioni e imprese), En Camello, CompartoCoche.com.ar, CompartoCoche.com, Coviajero, En Camino – che opera anche in Cile – e Carpling (attivo in Argentina, Colombia, Chile, Messico, Venezuela, Panamá e Viapool) (…). In Brasile invece c’è Caronetas, carpooling orientato a imprese e organizzazioni (…). La lista continua con ViajaConmigo Cile, Carpooling.cl, A Dedo, Colombia con EasyWay e Comparte tu Chevrolet (…), Voy Contigo in Uruguay e Aventones in Messico. Uno dei servizi più originali e interessanti è SaferTaxi per viaggi sicuri, agile e collaborativo nelle città dell’America latina (per ora Argentina, Brasile e Cile). Si tratta di un’applicazione per cellulari sviluppata per semplificare e modernizzare l’azione di ordinare un taxi e che include il profilo del taxi (…). La persona può accettare o rifiutare il driver (…).
Il car sharing invece sta guadagnando popolarità soprattutto in Città del Messico dove Carrot già funziona e Ubicar inizerà presto i suoi servizi. In Brasile, San Paolo ha avuto per lungo tempo Zazcar. Ma la mobilità non si esaurisce con auto, camion e biciclette pubbliche condivise, stanno guadagnando terreno, ad esempio, anche le EcoBici a Città del Messico (…) o Bikla a Guadalajara, MejorEnBici a Buenos Aires, Citycletas a Providence (Cile) BikeRio a Rio de Janeiro e PedalUsp presso l’Università di São Paulo (…). Che cosa ci manca? Servizi di noleggio auto come SocialCar P2P in Spagna o Getaround negli Stati uniti.
Il car sharing invece sta guadagnando popolarità soprattutto in Città del Messico dove Carrot già funziona e Ubicar inizerà presto i suoi servizi. In Brasile, San Paolo ha avuto per lungo tempo Zazcar. Ma la mobilità non si esaurisce con auto, camion e biciclette pubbliche condivise, stanno guadagnando terreno, ad esempio, anche le EcoBici a Città del Messico (…) o Bikla a Guadalajara, MejorEnBici a Buenos Aires, Citycletas a Providence (Cile) BikeRio a Rio de Janeiro e PedalUsp presso l’Università di São Paulo (…). Che cosa ci manca? Servizi di noleggio auto come SocialCar P2P in Spagna o Getaround negli Stati uniti.
Il crowdfunding come combustibile
Ovunque il crowdfunding (il finanziamento dal basso di progetti, soprattutto via web) ha registrato una crescita impressionante negli ultimi tempi. In Spagna ci sono più di 20 siti di crowdfunding e in America latina la tendenza continua. L’emergere di crowdfunding è importante perché la rivoluzione sarà finanziata collettivamente ed è lo strumento che fa da ponte tra il consumo e la produzione all’interno dell’economia collaborativa.
In Brasile abbiamo (…): Catarse, ItsNoon, Movere.me, Mobilitare, Começaki e Impulse (rivolto a imprenditori). Il crowdfunding è utilizzato anche nelle piattaforme sociali come Lets, SoulSocial, Tzedaka, Benfeitoria (…). In altri paesi è possibile trovare siti come Bandstic.me (per finanziare iniziative in Messico, con il supporto di Movistar) Idea.me (probabilmente la piattaforma più popolare in Argentina e uno delle più popolari in tutta l’America latina), LaLa (sito aperto di recente in Uruguay e focalizzato sulla produzione di film), InPact.me (… sito orientato a progetti sociali) o Lincipit (nato in Cile…). L’elenco continua con Proyectanos in Argentina, BananaCash, Groofi e NoblezaObliga (…). In Messico, non dobbiamo dimenticare La Fondeadora. Un’altra tendenza, almeno in Messico, è l’utilizzo di piattaforme come Kickstarter per finanziare progetti americani in Messico (…).
 In Cile abbiamo anche ShareTribe (per creare comunità da condividere), Koru (…), Mamaroof (alloggi per studenti), LocalGuiding, Cumplo, TomoClases, Aventones (carpooling), UniPlaces (alloggi per universitari in case private), CrowdPlaces (crowdfuding per spazi urbani), TuCreaz (mercato per artisti), Oja.la (istruzione online), Tu Closet Mi Closet (per lo scambio dell’abbigliamento) e TouristLink (turismo sociale) … e Startup Chilegite (carpooling) (…).
In Cile abbiamo anche ShareTribe (per creare comunità da condividere), Koru (…), Mamaroof (alloggi per studenti), LocalGuiding, Cumplo, TomoClases, Aventones (carpooling), UniPlaces (alloggi per universitari in case private), CrowdPlaces (crowdfuding per spazi urbani), TuCreaz (mercato per artisti), Oja.la (istruzione online), Tu Closet Mi Closet (per lo scambio dell’abbigliamento) e TouristLink (turismo sociale) … e Startup Chilegite (carpooling) (…).Città invisibile è un piccolo collettivo romano attento ai temi sociali e della decrescita.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)












